di Pierluigi Emesti*
Vorrei provare a condividere delle emozioni e delle riflessioni che mi stanno sorgendo dal cuore, dalla pancia e dalla testa.
Nel lavoro di cura di persone fragili, capita che si debba assistere a delle morti.
Ogni volta però è necessario secondo me prendersi il tempo necessario per accompagnare la persona dal nostro vissuto quotidiano all’album dei ricordi.
E’ successo recentemente che una ospite del centro per disabili dove lavoro sia mancata, dopo una breve ma cruenta malattia.
Come spesso capita non ce lo aspettavamo, parlo al plurale perchè tutta l’Equipe è stata disorientata da questa notizia, anche se la situazione di questa persona era molto debilitata e non facile.
In aggiunta abbiamo anche festeggiato, in sua assenza per malattia, il suo 50esimo compleanno. La famiglia ci teneva a farlo e anche noi tutti, è una prassi festeggiare insieme agli ospiti i compleanni. Il bigliettino le foto, il regalo, tutto finisce per diventare lavoro educativo da svolgere ognuno con le proprie capacità.
Comunque sia, Mimì non c’è più e nonostante la sua tetraparesi e l’assenza del linguaggio verbale, la sua presenza era occasione di intenso scambio di comunicazioni.
Per la sua peculiarità il lavoro di cura nei suoi confronti era delicato e impegnativo.
Purtroppo non abbiamo fatto in tempo a darle l’ultimo saluto e siamo rimasti delusi da questo, ci siamo sentiti un po’ tagliati fuori.
Eppure dal lunedi al venerdi per 47 settimane l’anno dalle 9 alle 16 abbiamo condiviso il nostro tempo.
Alcuni colleghi hanno fatto fatica a ricordare da quanto, forse 25 anni forse di più.
Insomma, un legame affettivo inevitabilmente e secondo me giustamente, si è venuto a creare. Abbiamo dedicato un incontro di supervisione a questo tema. In molti hanno espresso le loro emozioni e qualche ricordo con il magone, abbiamo forse fatto il nostro funerale laico.
A volte può succedere che la famiglia di appartenenza senta come unico il diritto al dolore, al lutto rinnegando ad altri un seppur ridotto potere di essere coinvolti.
E’ innegabile che l’impegno e la fatica sia per la famiglia molto più intenso, eppure anche coloro che hanno accolto, cantato, accompagnato in passeggiate, imboccato, pulito e salutato tutti i santi giorni, hanno sofferto per la scomparsa di questa persona.
Questa come tante altre!
Spero che si possa in futuro lavorare e costruire con le famiglie magari delle relazioni che sappiano riconoscere agli operatori un ruolo non solo socio-assistenziale-sanitario-educativo.
Abbiamo fatto tanta fatica a mettere la parola PERSONA davanti a disabile, proprio perchè sono sicuro che Antonio, Natale, Salvatore, sono persone insieme alle quali lavorare vorrei poter avere il diritto di essere triste se un “utente” scompare.
E’ poco professionale?
Forse chi investe poco in relazioni significative ritenendo che sia poco professionale lasciarsi coinvolgere, la pensa così. Vivrà sicuramente con meno delusioni e sofferenze. Ma anche con meno sogni e gioie inaspettate.
Difficile scegliere. Lo ammetto. Forse prendo tutte e due le opzioni.
*Educatore professionale
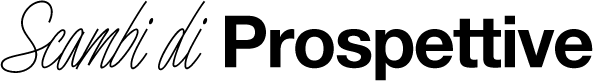

Evidentemente un centro come quello in cui tu lavori ha dinamiche diverse da quelle di un hospice per malati terminali in cui la permanenza raramente supera un mese, parli di 25 anni, sembra strano che tra la famiglia e gli operatori non si sia creato un legame più comunicativo, probabilmente ci sono diverse ragioni, provo a dirne alcune: la famiglia è così oppressa dalla cura quotidiana e dalla sofferenza che, ripiegata su se stessa, non coglie appieno l’impegno e l’empatia altrui, un certo ricambio degli operatori di riferimento rende difficile il crearsi di rapporti stabili, infine il genitore (o altro congiunto di riferimento) può ritenere, affidando ad altri la cura del paziente, sia pure per un tempo limitato, di venire meno a un suo compito e negando un ruolo “affettivo” all’operatore nega anche la sua incapacità di rispondere appieno alle necessità del paziente.
Alcuni operatori, infine, sentono più utile mantenere il rapporto su un piano professionale e meno “affettivo” o empatico proprio per tutelarsi dalla sofferenza, questa scelta può essere anche inconscia, anche questa è una scelta che ha diritto e dignità se operata comunque con attenta umanità.
Grazie per il tuo contributo Bernardo,
sicuramente le ipotesi che proponi sono ragionevoli e condivisibili, le abbiamo già esplose a suo tempo nel nostro gruppo di lavoro.
Quello che mi premeva sottolineare e dare corretta cittadinanza era la emozione che in parecchi abbiamo sentito nel venir meno una persona alla quale erano tutti abituati.
Permettimi però di fare emergere il fatto che se non provi una certa empatia con una persona che in pratica si muove molto poco e non verbalizza, quindi non ci puoi comunicare fisicamente o verbalmente….. puoi difenderti finchè vuoi, ma secondo me hai sbagliato lavoro. Punti di vista, scambi di prospettive.
concordo con queste belle e interessanti riflessioni dell’amico Pierre, sempre puntuale nel descrivere e farci partecipi di situazioni così lontane dal nostro quotidiano quanto poi presenti e simili alle esperienze di noi tutti almeno una o più volte nell’arco di una vita. Viva, evviva gli educatori sensibili alle esigenze delle persone e viva il loro coinvolgimento nella cura dei pazienti, ciao, Massi