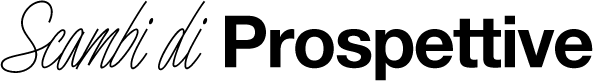di Irene Gallina*
Introduzione
Da decenni, in gran parte del mondo, viene ridiscusso il ruolo della donna nella società: prima con la sola rivendicazione di diritti come il suffragio universale, il divorzio, l’aborto, poi con l’elaborazione di teorie che fondino e accompagnino la lotta. L’evoluzione del discorso intorno al ruolo della donna ha visto il passaggio dal femminismo di separazione, che si allontana dal rapporto con il genere maschile, al femminismo intersezionale, che al contrario inserisce la lotta per i diritti delle donne all’interno del più ampio spettro dell’oppressione: le persone nere, quelle lgbtqia+, le donne, le persone con disabilità e con disagio psichico, le persone povere e quelle grasse subiscono tutte le stesse dinamiche di colpevolizzazione ed esclusione. Il femminismo intersezionale fornisce teorie e strumenti utili non solo alla lotta sociale, ma anche ad analizzare e interpretare la realtà con schemi differenti da quelli tradizionali, perché si concentra sulle dinamiche relazionali e sociali piuttosto che sulle caratteristiche degli oppressi o dei singoli gruppi sociali. Anche sul fronte clinico e su quello educativo l’intersezionalità potrebbe quindi costituire un approccio analitico e relazionale che purtroppo non è ancora stato esplorato a sufficienza. Sembra, anzi, che il contesto dei servizi alla persona sia isolato rispetto ai cambiamenti culturali che avvengono – seppur lentamente – nel resto della società. Basti pensare a quanto poco ci si formi e interroghi sulle modalità con cui le questioni di genere agiscono sulle relazioni educative, in un mondo che invece sta imparando a separare il ruolo genitoriale dal sesso biologico. O a come la maggior parte dei servizi educativi ignori la spinta pratica e teorica proveniente dall’attivismo delle persone con disabilità.
Così, l’ambito sociale che più di tutti dovrebbe e potrebbe promuovere il cambiamento, ne rimane tagliato fuori. Vogliamo qui tentare di bucare la bolla che circonda i servizi alla persona, concentrandoci sui vissuti delle educatrici, che spesso non lavorano in condizioni di parità rispetto ai colleghi educatori: dalla descrizione di come esse siano soggette a più stress e limitazioni, cercheremo di trarre riflessioni che possano creare un terreno fertile di discussione e dialogo.
Corpi, o dell’educatrice come donna
“Tu come rispondi quando ti chiedono se sei fidanzata?” è la domanda di molte giovani educatrici che affacciandosi al mondo del lavoro scoprono di dover imparare, e in fretta, a costruirsi un’identità in grado di resistere agli approcci degli utenti. Infatti, tra le prime competenze che non l’università, ma l’esperienza insegna, vi è la capacità di camuffare il proprio corpo, di dirottare gli sguardi, di inventarsi fidanzati inesistenti. D’estate, la vestizione dell’educatrice richiede accortezza: evitare gli shorts, i top troppo scollati, controllare che le camicette bianche non risultino trasparenti. È un processo talmente dato per scontato, che in breve tempo ci si ritrova ad avere un intero settore dell’armadio dedicato ai vestiti per il lavoro: non eleganti tailleur, ma t-shirts con il pregio di essere fresche e coprenti allo stesso tempo. È una strategia talmente interiorizzata, che ogni volta che fallisce provoca innanzitutto stupore: come può quella persona aver notato il mio seno, se esso non solo è nascosto, ma non è neanche del tutto mio, bensì appartiene al mio io-professionista?
Non esiste stacco tra lo sguardo sessualizzante dell’utente – o del collega – e la trasformazione in corpo: si passa repentinamente dall’essere professioniste in servizio all’essere semplicemente donne.
Sia chiaro, siamo qui lontane dalla demonizzazione della sessualità, in tutte le sue accezioni e sfumature: è perfettamente naturale che le relazioni educative incontrino attrazioni, infatuazioni, sessualizzazioni. È però altresì evidente come i servizi educativi e socio-sanitari non siano esenti dalla pervasività della cultura patriarcale, che spesso riflettono inconsapevolmente in pensieri e azioni.
Immaginiamo un mondo possibile in cui uomini, donne e persone non-binarie fossero considerate allo stesso modo: in una realtà di questo genere, le giovani educatrici non avrebbero bisogno di inventarsi un partner per sentirsi al sicuro, o per delineare i confini dell’asimmetria educativa. Al contrario, esse sarebbero ascoltate in quanto professioniste, a prescindere dal loro essere single o meno; né colleghi né utenti si permetterebbero di rivolgere loro sguardi oggettivanti o battute sessualizzanti, perché avrebbero chiaro che non si trovano di fronte a donne da ammaliare (o dominare), ma a educatrici con cui collaborare.
L’utente di un servizio che oltrepassa i confini posti dall’educatrice non lo fa né per natura né per devianza o disabilità, ma perché cresciuto e inserito in una società in cui la donna è e deve essere sempre approcciabile sessualmente; di conseguenza, la professionista è soggetta a uno stress lavorativo maggiore rispetto a quello che tocca i colleghi maschi. D’altra parte, però, manca un lavoro educativo in grado di contrastare gli insegnamenti del sostrato patriarcale e quindi volto non tanto ad aiutare la professionista oggettivata, ma a evitare in primo luogo che l’oggettivazione sussista. Così, l’educatrice che si affaccia al mondo del lavoro e subisce qualche commento inappropriato inizia presto a sentirsi in colpa e a ritenersi fallace sotto il profilo professionale: compra una t-shirt e impara a nascondersi.
Voci, o dell’educatrice come figlia
Non solo nascondere il corpo, ma anche il pensiero.
Il senso comune tende a definire il ruolo della donna come mediatore di conflitti piuttosto che detentore di opinioni e, così come in tutti gli ambiti di lavoro, anche in campo educativo le professioniste compiono più fatica dei colleghi per farsi ascoltare. Le giovani educatrici, spesso più preparate a livello teorico delle generazioni precedenti, devono fare i conti con l’idea diffusa e non sempre conscia che sono troppo giovani – e troppo donne – per avere opinioni precise e per sapere come realizzarle. Il confronto, in équipe o in riunioni di rete, spesso diventa una spiegazione che l’uomo di mezza età rivolge alla collega: quando non è una donna da osservare, l’educatrice è una figlia a cui insegnare come si lavora. Così, oltre a nascondere il corpo, essa impara presto a proporre le proprie idee a bassa voce o a presentarle come l’esito della mediazione di opinioni altrui per renderle più accettabili socialmente.
La tradizionale attribuzione di autorità e autorevolezza al genere maschile (mentre quello femminile è di solito caratterizzato da sensibilità, gentilezza e accondiscendenza) che determina queste dinamiche, si ripercuote anche sulle relazioni educative: nel mondo del sociale, infatti, è opinione comune che in ogni équipe debba esserci una componente maschile. Questa idea viene di solito presentata con due diverse argomentazioni:
- La figura dell’educatore maschio serve nella relazione con certi utenti che sono abituati ad ascoltare e a rapportarsi con gli uomini più che con le donne.
- La figura dell’educatore maschio serve per gestire al meglio i momenti di crisi. A questo proposito, si pensi come nel campo psichiatrico si dia particolare importanza alla presenza di colleghi uomini che possano condurre interventi contenitivi, verbalmente e fisicamente. Modalità che, tra l’altro, esplicita quanto siamo ancora lontani da un approccio dialogico e non autoritario al disagio psichico.
Assumendo che ogni proposizione poggia su strutture mentali e concezioni del mondo, (a) rivela l’incapacità dei servizi educativi di incidere sui paradigmi di pensiero che alimentano l’oppressione. Infatti, la richiesta di interagire principalmente con uomini, nella maggior parte dei casi, è determinata da pregiudizi di stampo discriminatorio: di conseguenza, il servizio che dà il proprio assenso a questa richiesta lo dà implicitamente anche alla forma logica patriarcale per cui è accettabile ascoltare di meno le donne. È evidente come un intervento di questo tipo non sia davvero educativo, bensì risponda a esigenze pratiche, di solito determinate dalla fretta di stabilire relazioni che riescano a contenere le emergenze. Invece, si potrebbe intervenire in molti modi senza passare un implicito messaggio di svalutazione delle educatrici: per esempio, si potrebbe instaurare un dialogo con l’utente riguardo alla sua difficoltà a interagire con le donne, o si potrebbe spiegare che le competenze educative non variano in base al genere. Queste soluzioni non solo eviterebbero di rappresentare la professionista come legittimamente trascurabile, ma sostituirebbero anche lo sterile assenso con la creazione di spazi di dialogo – e quindi con la possibilità di generare cambiamento.
Nell’analizzare (b), tralasceremo di affrontare il tema del contenimento fisico, che dovrebbe semplicemente essere abolito tramite la costituzione di servizi che antepongano la relazione e la prevenzione alla gestione dell’emergenza. Proviamo invece a chiederci cosa serve per gestire i momenti di crisi: una relazione educativa consolidata, autorevolezza, fermezza, sicurezza di sé, capacità di ascolto e di intuire i tempi del dialogo, pazienza, capacità di cura, confronto con i colleghi e sostegno dell’équipe. Nessuna di queste competenze è imputabile a un genere piuttosto che a un altro. Di conseguenza, delegare l’azione del contenimento al genere maschile significa (i) relegare la mascolinità in un ruolo paternalista che non ha origini biologiche e (ii) definire la relazione educativa solo in un’ottica emergenziale.
In definitiva, le argomentazioni con cui si giustifica l’assegnazione di alcuni interventi agli educatori non sono legittimamente fondate, perché entrambe derivano dalla convinzione, non supportata scientificamente, che gli uomini riescono a essere più autorevoli delle donne. Tuttavia, pur non avendo validità logica, queste argomentazioni sussistono e contribuiscono a togliere voce alle educatrici, che devono lottare più dei colleghi sia per trovare un posto di lavoro, sia per farsi ascoltare in équipe e ritagliarsi i propri spazi di azione educativa.
Conclusione
I servizi educativi e socio-sanitari sono per definizione portatori di cambiamento, nelle vite delle persone e nella società tutta. Eppure, la differenza di livelli di stress a cui sono soggetti i professionisti e le professioniste che vi lavorano rispecchia esattamente la struttura oppressiva del sistema sociale. Proprio perché l’educatore è agente di trasformazioni culturali e sociali, non vedere la discriminazione che le educatrici affrontano sul posto di lavoro significa rinunciare alla possibilità di intervenire sulla cultura maschilista che ci circonda. Invece, per essere davvero portatori di cambiamento, dobbiamo interrogarci su quanto e come le strutture logiche su cui si fonda la nostra società oppressiva influenzano il nostro agire professionale. E se troveremo che esse permeano pensieri, azioni e relazioni educative, modificandole nei nostri servizi potremo contribuire a scardinarle nella società intera.
*Educatrice professionale