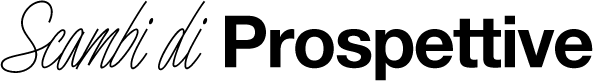di Patrizia Taccani*
Il significato dell’identità: per sé, per gli altri
Da qualunque prospettiva la si guardi – filosofica, psicologica, antropologica, sociale – l’identità ci si presenta come un insieme di caratteristiche che riguardano la persona viva e vitale, segni distintivi di cui, di norma, c’è consapevolezza individuale e riconoscimento da parte degli altri. Dell’identità si riconosce la sua continuità nel tempo, ma anche la sua trasformazione lungo il ciclo della vita, con parziali modificazioni fortemente influenzate dal contesto sociale e dagli eventi critici che un individuo si trova ad affrontare. L’identità riguarda corpo, mente, affettività, relazionalità, cultura. Essa ricopre un ruolo cruciale in quanto identità sociale nel permetterci di muoverci nel mondo.[1]
Certamente la cosa più immediata per riconoscere l’identità di una persona sono il suo nome e cognome che sempre e comunque precedono ogni altro dato su un documento di identità, appunto. Il nome e cognome e la data di nascita continuano a identificare – sulle iscrizioni funerarie – anche le persone morte: le epigrafi hanno origine nell’antichità classica e potremmo sintetizzarne la funzione nell’espressione incisa su una tomba: “Pronunziare il nome di un uomo significa veramente farlo rivivere”.[2] La stessa pratica del cenotafio dove i famigliari, pur di far memoria di una persona cara, ne iscrivono il nome su una pietra o un monumento che tuttavia non ne ricopre le spoglie, riveste il significato di dare presenza a chi è diventato un assente. L’identità, dunque, ha a che fare anche con la memoria, la nostra e quella altrui. Conosciamo il dramma di stermini di massa che hanno avuto la caratteristica della sistematica cancellazione dell’identità delle vittime, con l’annientamento psichico, poi con quello fisico e infine, con la spaventosa pratica delle fosse comuni.[3] Da qui, ancora una volta, la volontà dei viventi di erigere memoriali: monumenti, o anche solo muri, con incisi i nomi delle vittime, là dove siano state rintracciabili le identità prima violate e poi distrutte.
“Ottobre 2013. Dare un nome ai morti”
Questo il titolo che Cristina Cattaneo[4] ha dato al primo capitolo del suo recente libro “Naufraghi senza volto”.[5] L’Autrice con la data dell’ottobre 2013 vuole indicare l’inizio di una nuova storia nella quale fa cenno all’intreccio tra il personale vissuto di perdita di un proprio caro e una delle prime grandi tragedie del mare: il naufragio di un barcone con a bordo 400 migranti eritrei, il 3 ottobre 2013, vicino alle coste di Lampedusa. Pochi giorni dopo analogo destino avrà un barcone con profughi provenienti dalla tormentata terra siriana.
“Le schede con i volti delle vittime, i documenti e le fotografie portate dai parenti che cercavano e cercano ancora quei corpi, riempiono oggi gli scaffali del nostro laboratorio. Nelle menti di questi padri, fratelli, figli, mariti, oltre all’angoscia e alla frustrazione, si annida lo strazio di chi non ha potuto seppellire né onorare il corpo del proprio “caro”, e si chiede ancora oggi dove sia”. (p.9)
Dopo questo esordio Cristina Cattaneo apre una parentesi sulla attività del LABANOF nel quale “ci occupiamo […] di restituire una storia, un’identità, e persino la dignità, a resti umani, qualunque sia la forma in cui si trovano e a qualunque epoca appartengano […]”.(p.10)
Perché e come si può parlare di restituzione della dignità? Lo si può fare proprio perché lo sforzo dei professionisti[6] implicati nell’attività di riconoscimento dei resti umani si muove, ed è sostenuto, dal profondo convincimento del valore della persona venuta al mondo, anche quando – dopo la sua morte – le circostanze sembrano avergliela completamente sottratta. Questo vale per i “nostri” morti – scrive chiaramente l’Autrice – e deve valere per tutti i morti, compresi dunque i migranti naufragati e sepolti in fondo al mare.
«Quando c’è un disastro aereo, come quello di Linate del 2001, giustamente lavoriamo per dare la possibilità a chi è rimasto di piangere su un corpo. E allora perché non dovremmo farlo anche per i migranti morti nel Mediterraneo?».
Tutti hanno il “sacrosanto diritto” ad avere il proprio nome anche dopo la morte.
Il dolore dei famigliari e il loro bisogno di “sapere”
C’è dunque una dignità umana da riconsegnare, contestualmente alla restituzione dell’identità della vittima. Ma non c’è solo questo. Dalle pagine di Cristina Cattaneo escono riflessioni personali che derivano dalla sua formazione culturale e professionale, ma anche dai tanti incontri avuti con i famigliari delle persone scomparse o delle vittime non riconosciute.
“All’inizio pensavo che non fosse difficile immaginare l’angoscia di chi rimane in questo limbo. Poi però mi resi conto di come non mi fossi neanche avvicinata, con l’immaginazione, al tipo di sentimento provato da queste persone quando mi confrontai con il volto, reso quasi inespressivo dagli anni di incertezza, della madre di una ragazza sparita ormai da vent’anni.” (p.13)
É proprio su questo dolente aspetto che il libro si sofferma più e più volte nelle pagine dedicate alla ricerca del riconoscimento dei migranti morti in mare. Quasi a rispondere a una delle tante obiezioni (quando non aperte critiche) all’operato suo e dei colleghi – quella che i naufraghi muoiano nel Mediterraneo nell’indifferenza delle famiglie – Cristina Cattaneo mostra nei fatti come i parenti cerchino con tutti i mezzi a disposizione di conoscere la sorte di chi è dato per disperso. Rispondere a questo bisogno non è soltanto questione umana, civile, etica: la restituzione della verità su una persona scomparsa ha anche a che fare anche con la tutela dei vivi. Si pensi al diritto di un minore rimasto orfano e dichiarato tale dall’identificazione del corpo del genitore, ragazzo che potrà essere accolto da un altro parente sia nel paese di origine, sia con un ricongiungimento là dove si trovi l’adulto disposto a prendersene cura.
Parlare con i parenti fa parte del lavoro di riconoscimento del morto e ciò che il libro comunica è che “non ci si abitua mai”. Certo, viene da pensare, perché è il modo con cui viene fatto, un modo professionale e colmo di pietas al tempo stesso. Un modo che cerca di immaginare il dolore, che accetta la rabbia, che accoglie fiumi di parole disperate allo stesso modo di lunghissimi silenzi. Sono sorelle, zie, padri, mariti, una nonna che cerca il padre della nipotina, compagni, anche amici. Portano foto, parlano di cicatrici, di nei, di tatuaggi, di denti spezzati per una caduta; guardano biglietti con numeri telefonici sbiaditi, oggetti rinvenuti nelle tasche dei giubbotti, cuciti all’interno di una tasca, un giocattolo, una bustina con dei soldi… E poi sfogliano le raccolte delle foto scattate dall’équipe degli operatori e conservate negli schedari con cura, contrassegnate da un numero che è stato scritto con la mai abbandonata intenzione di sostituirlo con un nome.
Cristina Cattaneo e tutte le persone che hanno collaborato e collaborano con lei vogliono rendere sempre più ridotto il numero di persone costrette a convivere con il dolore, lo smarrimento, l’angoscia che accompagnano una “perdita ambigua”, vissuti che assalgono i vivi quando non conoscono quale sia stato il destino di un loro caro. Solo con la certezza della perdita, infatti, si può dare inizio al processo di elaborazione del lutto.
Dopo le tragedie dell’ottobre 2013 con un lavoro durato un anno e mezzo circa,
“alla fine intervistammo le famiglie di settanta scomparsi in quei due disastri, in prevalenza eritrei, parenti delle vittime del 3 ottobre. I familiari si erano mossi da tutta Europa: Italia, Germania, Svizzera, Svezia, Norvegia, Inghilterra. Centosessanta persone si mobilitarono per cercare i loro morti […] alla faccia di chi diceva che questi morti non li cercava più nessuno.” (pp.83-84).
Nel racconto del lungo lavoro di riconoscimento hanno particolare rilievo le due espressioni che troviamo nel testo, ante mortem e post mortem: la prima riguarda la raccolta di ogni elemento collegato alla vita della persona da confrontare con ciò che ne “resta”, dal cui confronto si cerca di arrivare a trasformare il numero identificativo in un nome, e a poter stilare infine un certificato di morte. Oltre al fondamentale aspetto civile di questo paziente lavoro di ricostruzione si è venuto perfezionando un modello scientifico di lavoro nel campo della medicina legale “umanitaria”: con quest’ultimo aggettivo viene connotata nel testo.
Il 18 aprile 2015, al largo di Lampedusa, la tragedia più terribile: 1000 morti, e il relitto di un barcone blu che resta come simbolo dell’immane perdita di vite umane.
“Ancora oggi mi sembra incredibile e commovente pensare a come le più grandi agenzie italiane come la Marina Militare, Università, i Vigili del Fuoco insieme a molti altri si siano spesi – in un periodo storico in cui, nel parlare di supporto ai migranti, si viene spesso trattati con sufficienza o biasimo – non solo per recuperare un barcone pieno di vittime dalla pelle scura, ma anche per trattarli come tratteremmo mille europei “bianchi” […] e cioè recuperare i corpi, sottoporli a dettagliate analisi scientifiche, seppellirli e cercarne i parenti, cosa mai fatta da nessun Paese in questi anni di attraversamenti letali del Mediterraneo.” (p.99).
Frammenti di storie
Sì, sono frammenti di storie, non le potremmo definire storie di vita, tanto minuscoli sono gli indizi che ne permettono la breve narrazione. E non potrebbe essere diverso. Forse la più conosciuta è quella di un ragazzo di 14 anni proveniente dal Mali annegato il 18 aprile 2015. A raccontarla la sua pagella piena di buoni voti scritti in arabo e francese, ripiegata e cucita nel risvolto di una tasca.
Sappiamo quindi che andava a scuola, che era “bravo” negli studi, che, forse, aveva custodito la pagella con grande cura come prova della sua volontà di impegnarsi anche lontano da casa, forse come lasciapassare per una nuova vita. Un gruppo di coetanei italiani con la preside e gli insegnanti gli ha dedicato una pietra d’inciampo nell’atrio della scuola superiore dove rispettivamente studiano e lavorano. Perché di questo ragazzo non si perda il ricordo, sulle orme di chi ne ha poste centinaia in tutta Europa e non solo, a memoria delle vittime del nazifascismo.[7] O l’altrettanto breve storia del ragazzo del Gambia che aveva portato con sé, in tasca, cinque documenti tra cui la tessera di una biblioteca e il tesserino da donatore di sangue. Proprio come uno dei nostri figli, uno dei nostri nipoti, come la ragazza della porta accanto o lo studente che tutte le mattine prende il treno dei pendolari per arrivare a lezione.
E poi ci sono singoli oggetti che da soli non possono raccontare una storia, neppure un frammento di storia: come un piccolo dente da latte, una maglietta con Spiderman, un distintivo della Juventus, un Corano, una croce ortodossa, un pugno di terra natale nascosta e protetta in una piccola sacca ricavata nella T-shirt. Eppure ciascuno di questi rimanda a una persona che in tutti i modi l’équipe di Cristina Cattaneo cercherà di sottrarre all’anonimato, con un paziente lavoro scientifico che “consiste nel far raccontare i morti attraverso i loro resti umani e quello che ciascuno di loro portava con sé.”
In una delle tante interviste che fortunatamente giornali e televisioni le hanno fatto, Cristina Cattaneo ha parlato della sua “necessità” di scrivere questo libro. Ha cioè spiegato l’urgenza di far conoscere oggi un aspetto sottaciuto (o spesso rimosso) del dramma migratorio dei nostri tempi, la sparizione di migliaia di persone in mare; ma ha detto anche della sua paura che fra cinquant’anni nessuno abbia più ricordo proprio di queste persone morte nel tentativo di fuggire da guerre, dittature, violenze, fame.
Un preciso messaggio civile e politico. Ora la necessità deve muovere noi lettori di “Naufraghi senza volto”: per raccogliere il messaggio, diffonderlo. [8]
Note
- [1] Jervis G., Presenza e identità, Garzanti, Milano 1984.
- [2] Cfr. Nicosia S., Il segno e la memoria. Iscrizioni funebri della Grecia antica, Sellerio Editore, Palermo 1992.
- [3] Cfr. Bruneteau B., Il secolo dei genocidi, il Mulino, Bologna 2006.
- [4] Cristina Cattaneo è Professore Ordinario di medicina legale presso l’Università degli studi di Milano e Direttore del LABANOF (Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense).
- [5] Cattaneo C., Naufraghi senza volto. Dare un nome alle vittime del Mediterraneo, Raffaello Cortina Editore, Milano 2018.
- [6] Sono medici legali, biologi, antropologi, odontoiatri, naturalisti, archeologi.
- [7] Iniziativa dell’artista tedesco Gunter Demnig a partire daglia anni novanta.
- [8] In questo volume si tratta ampiamente sia dell’affinamento di metodologie e strumenti scientifici nel campo della medicina legale con un grande investimento professionale da parte dei membri dell’équipe del LABANOF e di altre Università; sia dello straordinario sforzo di coordinamento e di collaborazione tra istituzioni italiane diverse, in particolare per e dopo il recupero del “Barcone” affondato con mille migranti. Per evidenti ragioni di spazio questi aspetti non sono stati qui trattati come meriterebbero.
*Psicologa, formatrice, redattrice di Prospettive Sociali e Sanitarie