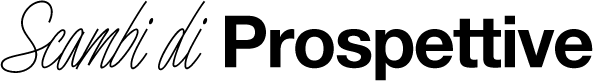Diversi anni or sono, lo storico francese Marc Bloch ha scritto un bel libro (1) sulla diffusa credenza popolare, radicata dal 500 dopo Cristo sino alla fine del 1700, che attribuiva ai re di Francia il potere di eliminare la scrofola (una forma di infezione tubercolare) tramite l’imposizione della mani, il cosiddetto “toccamento del re”. Nel welfare italiano è certo possibile che alcuni assistenti sociali si occupino tuttora di tubercolosi, ma non risulta (per fortuna) che l’imposizione delle mani sia una pratica professionale in uso.
Dunque perché abbinare la capacità di taumaturgo alla figura dell’assistente sociale? Ecco alcune possibili ragioni per riflettere sul tema, che si potrebbe estendere anche ad altre professioni di aiuto proponendolo in questo modo: esistono rischi (e quali) quando il sistema di welfare tende a confidare troppo sulla capacità del singolo operatore? E, per converso, vi sono “tentazioni di onnipotenza” possibili per gli operatori, e perché potrebbero essere un problema?
Quando è il sistema di welfare che confida in facoltà illimitate degli operatori
Alcuni esempi:
- Può essere un agevole alibi per le politiche e per la normativa assegnare al solo ruolo professionale dell’operatore nodi che invece meriterebbero decisioni più a monte, “di sistema”. Ad esempio la normativa sull’Isee prevede che i servizi sociali debbano “attestare l’estraneità affettiva ed economica” di figli non conviventi con il non autosufficiente che presenta il suo Isee, oppure di genitori non conviventi con i figli e non coniugati con l’altro genitore. E da questa attestazione derivano importanti conseguenze per i cittadini, i quali dovranno (o meno) far presentare un Isee anche ai non conviventi, e vedranno (o meno) crescere il loro Isee di conseguenza. Ma la normativa sull’Isee ha introdotto nell’ordinamento il concetto di “estraneità affettiva ed economica” senza per nulla articolarlo nei contenuti e nelle procedure di istruttoria. Con l’effetto dunque che ove le regioni od i singoli Enti gestori dei servizi sociali non hanno con propri atti precisato “che cosa è” e “come si accerta” quella condizione (il che è avvenuto in pochi territori), da un lato i singoli operatori devono inventarsi un criterio interpretativo, e dall’altro i cittadini incontrano scelte molto diverse nei territori, spesso derivanti dalla personale propensione dell’operatore.
- Non è difficile incontrare dispositivi anche normativi che esprimono l’integrazione tra diversi segmenti del welfare, quando necessaria per fronteggiare i bisogni, come una mera enunciazione, come un “dover essere”; quasi che fosse sufficiente evocare la parola “integrazione” perché essa si autorealizzi. Un esempio è il “Piano per le Cronicità”, ed anche il dPCM 12/1/2017 che ha introdotto i nuovi Lea, nel quale quasi ogni articolo del Capo IV (dedicato alla assistenza sociosanitaria) si limita a recitare che l’assistenza sanitaria “…è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale” .
Non c’è dubbio che un lavoro integrato tra diversi servizi dipenda anche da quanto si spendono allo scopo i singoli professionisti; ma è utile chiedersi se non vi sia il rischio di:
- eludere scelte e responsabilità dei governi del sistema nell’attivare meccanismi (istituzionali ed operativi) che sono la necessaria precondizione per un’azione integrata degli operatori. Stante la segmentazione dei servizi in diversi apparati ed istituzioni (basti pensare alla filiera che deve percorrere un non autosufficiente e la sua famiglia), è illusorio pensare che “a ricucire e ricomporre” i percorsi nel welfare siano solo le azioni dei singoli operatori. Così come muovere verso un “budget di cura” (ossia l’utilizzo di risorse economiche di più servizi da unire per attivare prestazioni utili) non è certo obiettivo connesso alla sola competenza professionale degli operatori;
- confondere “l’integrazione delle professioni” con “l’integrazione delle prestazioni”. Ad un paziente dipendente da sostanze o con problemi psichiatrici può certo essere utile trovare Sert e servizi di psichiatria che includono diverse professionalità (sociali e sanitarie). Ma è altresì utile che in quei luoghi possa trovare anche risposte connesse ai bisogni di reddito o di abitazione; e poiché queste funzioni spettano a servizi di altri Enti (ad esempio i Comuni), senza intese istituzionali non è certo sufficiente che “…gli operatori collaborino”.
C’è anche una conseguenza connessa all’impiego delle risorse professionali: non basta immettere assistenti sociali (o altre professioni del sociale) per generare “di per sé” meccanismi integrativi tra pezzi del welfare utili al cittadino. Collocare assistenti sociali entro servizi sanitari dedicati a progettare la continuità della cure nel percorso di un non autosufficiente (dimissioni dall’ospedale – inserimento in struttura di riabilitazione – ritorno a casa ma con assistenza domiciliare robusta, oppure inserimento in struttura residenziale per non autosufficienti) non è misura sufficiente se non si governa la filiera e il raccordo dei diversi servizi sia con strumenti istituzionali (intese tra enti) che organizzativi (protocolli non casuali).
Su aspetti come questi, dove pesano sugli operatori responsabilità difficili da gestire se mancano presupposti normativi e/o organizzativi, c’è comunque un importante compito professionale: non stare zitti, sollevare problemi, esporre proposte. Compito che è “professionale” perché non si tratta solo di “difendersi da responsabilità improprie”, ma anche di irrobustire i diritti dei cittadini entro i meccanismi del sistema di welfare. Ma questo implica per l’operatore anche lo spendersi (ed esporsi) per modificare organizzazione e politiche.
Quando è l’operatore che rischia di assumersi ruoli taumaturgici
Snodi da controllare per evitare una trappola di presunta onnipotenza:
- E’ sempre utile riflettere sui rischi che Robert Merton[note]R. K. Merton, Teoria e struttura sociale, Bologna, il Mulino, 2000.[/note] segnalava per chi lavora in contesti dove i rapporti con i clienti sono regolati da criteri e meccanismi definiti: difendersi dai conflitti con gli utenti attribuendo le colpe alle norme o all’organizzazione, scambiare l’obiettivo del proprio lavoro (le persone in difficoltà) con l’esecuzione di procedure, “nascondersi” nel ripetitivo ritualismo delle prassi burocratiche. Ma è possibile anche il rischio inverso: confidare nella propria capacità di operatore come risolutiva dei problemi insiti nelle regole dell’operare e nei criteri per gli interventi. Anzi sperare che “la professionalità” possa sostituire da sola i cattivi meccanismi dell’organizzazione o delle norme. Certo può essere labile il confine tra quanto un buon intervento deriva da ciò che l’operatore può fare con la sua competenza e quanto invece dipende da processi e criteri dell’istituzione. Merita tuttavia chiedersi se e quando l’operatore che vede criticità che ricadono sugli utenti non riconosce che vanno migliorate “nel sistema”, e non solo “nell’agire professionale del singolo”. Ad esempio è il singolo assistente sociale che può inventarsi un progetto individualizzato per l’attivazione dei beneficiari del ReI, confidando solo su una sua capacità diagnostico/terapeutica? Oppure anche un approccio “clinico” è efficace solo se si innesta in un sistema di servizi che sa costruire concrete opportunità di inserimento sociale, anche ingaggiando altri attori locali (diversi servizi, terzo settore)?
- Da tempo è chiaro che il lavoro sociale non deve consistere solo nell’erogare prestazioni prefabbricate. Ma è bene che alcuni interventi abbiano invece contenuti derivanti da criteri oggettivati, ad esempio le erogazioni economiche a sostegno dei redditi inadeguati. Quelle nazionali poggiano su norme che ne presidiano i meccanismi; quelle locali (ad esempio l’assistenza economica erogata dai comuni o dai loro enti gestori) derivano quasi ovunque da regolamenti degli enti gestori. E in taluni territori operano meccanismi nei quali molti dei criteri di accesso, e l’importo da erogare, sono decisi dagli assistenti sociali. Il nodo su cui riflettere può essere espresso in questo modo:
- non c’è dubbio che la professionalità dell’operatore sia indispensabile per inserire l’aiuto economico entro un progetto più organico di supporto, e che poggi anche su “condizionalità” richieste ai beneficiari;
- ma siamo sicuri che affidare ai singoli operatori la decisione di “quanto” erogare, e/o dei criteri fondamentali per ricevere la prestazione, non rischi da un lato di privare i cittadini di criteri trasparenti e dall’altro di impegnare gli operatori in compiti per i quali non esiste una strumentazione professionale solida e condivisa, con il rischio di una eccessiva discrezionalità non presidiabile?
Questo assetto può certo essere annoverato tra le tipologie di cui al punto 1 (alibi assunti dalle politiche), ma una simile discrezionalità è a volte anche rivendicata dagli operatori.[note]Va ricordato che l’articolo 12 della legge 241 prevede che la concessione di qualunque forma di contributo è subordinata alla predeterminazione e pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri ai quali attenersi. Se gli Enti gestori non hanno assunto regolamenti peccano di omissione; ma se nel regolamento hanno previsto solo che criteri ed importi li decide un operatore, peccano di tautologia (l’ente decide solo… che decide qualcun altro).[/note]
Non è certo un dilemma nuovo, ma è sempre utile interrogarsi se i vincoli organizzativi sono davvero una “gabbia di ferro” che impedisce un buon lavoro professionale o se invece possono essere usati (o trasformati) per diventare risorsa, offerta ai cittadini meno casuale, moltiplicatore dell’azione tecnica. E per contro soprattutto per discipline come il servizio sociale, con deboli evidenze dei legami tra azioni e risultati, resta un dovere dell’operatore saper spiegare perché ha assunto le sue scelte, senza scambiare la competenza col buon senso.
Tra i nodi del punto 1) e 2) c’è anche una “terra di mezzo”: attività che le norme hanno “abbastanza” delineato, e per le quali nell’assetto organizzativo si possono essere previsti meccanismi, ma che richiedono anche un accumulo di esperienze professionali. Un buon esempio può essere quanto il ReI prevede rispetto al “progetto personalizzato” che va attivato dai servizi in parallelo all’erogazione economica. Certo in merito possono anche essere necessari più strumenti “dall’alto” [note] Ed infatti è prevista ad esempio l’emanazione (a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) di linee guida e strumenti per la valutazione multidimensionale[/note], ma non c’è dubbio che sia un terreno nel quale “si impara facendo”, e quindi ben vengano strumenti che aiutino ad “imparare dagli errori” ed a socializzare pratiche positive. Perché non attivare una “bacheca di esperienze” a cura del Ministero? O nelle comunità professionali?
(1) ) I re taumaturghi, uscito nel 1924 e pubblicato poi da diversi editori.
*Docente a contratto presso l’Università di Torino (Laurea Magistrale in Politiche e Servizi Sociali e Laurea triennale in Servizio Sociale); redattore Prospettive Sociali e Sanitarie.
Questo articolo è stato pubblicato anche su welforum.it.