di Diletta Cicoletti
 Mi capita di pensare a come si debba sentire un assistente sociale o un educatore appena laureato oggi. Ma siccome questo pensiero rischia di essere totalmente sganciato dalla realtà (perché non sono giovane, non sono operatore sociale, non so cosa vuol dire esattamente laurearsi oggi in servizio sociale o in scienze dell’educazione) posso provare a capirlo ascoltando le voci di chi cerca, di chi vuole costruirsi una propria professionalità, di chi vuole provare a mettere a frutto le conoscenze acquisite nei corsi di studi e nelle esperienze di tirocinio e accrescere competenze. Magari insieme ad uno stipendio, ad un percorso in un’organizzazione, con la possibilità di essere accompagnato (ma non troppo) nelle future decisioni.
Mi capita di pensare a come si debba sentire un assistente sociale o un educatore appena laureato oggi. Ma siccome questo pensiero rischia di essere totalmente sganciato dalla realtà (perché non sono giovane, non sono operatore sociale, non so cosa vuol dire esattamente laurearsi oggi in servizio sociale o in scienze dell’educazione) posso provare a capirlo ascoltando le voci di chi cerca, di chi vuole costruirsi una propria professionalità, di chi vuole provare a mettere a frutto le conoscenze acquisite nei corsi di studi e nelle esperienze di tirocinio e accrescere competenze. Magari insieme ad uno stipendio, ad un percorso in un’organizzazione, con la possibilità di essere accompagnato (ma non troppo) nelle future decisioni.
Nel 2015 la XVII Indagine di Almalaurea è stata presentata al convegno “I laureati tra (im)mobilità sociale e mobilità territoriale” (maggio 2015), mai titolo di convegno fu tanto evocativo e centrato. I laureati in generale fanno i conti con il dato della difficile mobilità sociale: la laurea non fa più la differenza. Non sai se troverai un lavoro che, come si diceva una volta, ti ripaghi dell’investimento in studio e quindi produca reddito (su questo sarà un’interessante lettura il libro di prossima uscita “Eredità dei saperi” per Cortina, a cura di Francesco Cappa, su cui ritornerò presto). Quindi non sei più inserito automaticamente nella scala sociale. Per cercare di sbloccare le proprie vite i laureati sono mobili sul territorio nazionale e internazionale, cercando riconoscimenti, riponendo speranze in viaggi che spesso rischiano di essere molto “a tempo determinato”.
Non è un argomento di poco conto e certamente non ho qui l’intento di semplificare processi e percorsi così faticosi e difficili per singoli e famiglie, chiamate a sostenere queste mobilità nonostante non siano sempre foriere di sicuri guadagni. Almeno nell’immediato. Tanto che il primo contratto di lavoro è ancora nell’area dell’“investimento personale, poi vedremo, intanto faccio qualcosa che mi serve”.
I post che si trovano su facebook, in alcuni dei gruppi professionali più popolati e attivi di assistenti sociali ed educatori, raccontano di una realtà faticosa, ai limiti della sopportabilità. Una realtà che spesso toglie speranze e fa vedere solo i limiti della fase che stiamo attraversando. Dai post si capisce che la meta di questo viaggio è difficilmente individuabile prima della partenza: i post ti portano in giro per l’Italia e, a volte, per l’Europa. Spesso senza molte distinzioni o preferenze, l’importante è trovare un lavoro o un tirocinio con cui accumulare esperienze. Un dato che ricorre è la ricerca verso nord, ci si muove spesso verso nord. Anche dal nord Italia, sempre verso nord. Non si cercano necessariamente opportunità di lavoro nel settore più interessante per sé, troppo difficile e raro trovare risposte vicine ai propri interessi, con un contratto di lavoro regolare, qualche sicurezza per il futuro. Spesso gli operatori sociali nei loro scambi chiedono se gli stipendi siano regolari o se si lavora con partita IVA, se sono rispettati i contratti, riconosciuti gli straordinari.
Dunque nessuna certezza sul versante contrattuale, quindi entrate saltuarie, stipendi sotto la media, tutele azzerate. Insomma Im-mobilità sociale assicurata. D’altra parte richiesta di massima flessibilità, autonomia, disponibilità a fare un po’ di tutto e su tutto il territorio nazionale. I giovani operatori si trovano nella spiacevole situazione di dover accettare compromessi sempre più al ribasso, di dover allentare la presa su proprie specifiche attitudini in qualche caso “accontentandosi” per poi “sperare” in qualcosa di meglio.
Se questo è lo scenario e la realtà di tutti i giorni, quali sono i problemi?
Non voglio qui trattare la materia contrattuale, che tuttavia avrebbe bisogno di essere molto approfondita, ma provo ad interrogarmi sull’attualità del lavoro sociale. Mi domando quanto queste attese o questi desideri siano connessi con i cambiamenti in atto nei contesti sociali e nei servizi sociali ed educativi. Percepisco molta distanza tra le attese e le possibili risposte. Mi sembra che in alcune realtà si stia praticando un welfare che richiede un coinvolgimento diverso. Un welfare che richiama al lavoro degli artigiani, cioè di “chi esercita un’attività (anche artistica) per la produzione (o anche riparazione) di beni, tramite il lavoro manuale proprio e di un numero limitato di lavoranti, senza lavorazione in serie, svolta generalmente in una bottega” (Dizionario Treccani), al lavoro degli artigiani-ricercatori, pensiero ripreso in una recente pubblicazione della collana Clinica della formazione di Franco Angeli del Centro Studi Riccardo Massa dal titolo “Educare e ricercare”, a cura di Paola Marcialis. Operatori che oltre all’essere artigiani devono provare ad essere attori di un teatro dell’improvvisazione, guidati da un profondo senso di appartenenza alla professione e dalle metodologie di lavoro, che oggi sembrano essere diventate un ancoraggio nelle incertezze. Per esempio: come lavorare con le nuove povertà? Come avvicinare o entrare in relazione con utenti così simili a noi? Quali sguardi attivare e quali pratiche mettere in campo?
Trovo tutte le domande e tutte le interazioni sui social network più che legittime e centrate, ma non vedo un modo facile per far sentire i giovani operatori meno scoraggiati e più speranzosi. Per permettere che alcune cose cambino in meglio a breve, sarebbe necessario un movimento politico mirato ed un investimento preciso. Che oggi manca nonostante ci siano condizioni di mercato che aprono spazi interessanti. Per esempio Italia Lavoro e anche il Censis mettono in luce che:
“Oggi c’è una domanda crescente di salute, assistenza, previdenza per avere la sicurezza di un futuro lungo e in buone condizioni. A questa domanda risponde la «White Economy», cioè la filiera delle attività sia pubbliche che private riconducibili alla cura e al benessere delle persone. Ha ormai raggiunto un valore di 290 miliardi di euro, corrispondente al 9,4% della produzione complessiva nazionale. E sono 2,8 milioni gli addetti che operano in maniera diretta nei suoi diversi comparti. A questi vanno aggiunti i posti di lavoro che si generano «a monte» e «a valle» come indotto delle attività considerate, che innalzano il numero degli addetti totali a 3,8 milioni, pari al 16,5% degli occupati del Paese”.
Se oggi la White Economy è un mercato in espansione, se la domanda di salute e di benessere è al centro nella società contemporanea, che cosa tiene così lontano il sistema di welfare (pubblico e privato) da questa spinta propulsiva? Un retaggio culturale? Una faticosa attualizzazione delle domande sociali? Una struttura del welfare sociale non più al passo con la complessità del vivere contemporaneo?
Io non sono per accontentarsi
E, giusto per aggiungere altra carne al fuoco, mi domando anche quanto l’università possa avere un ruolo nel cambiamento che stiamo attraversando. Cambiamento che ancora è così poco visibile e percepito, mentre sembra ancora così vitale la rappresentazione della crisi.
Non so se possiamo dire ai nostri G.O.S.S. “come fare”, ma forse possiamo cominciare a dirci che cosa significa fare lavoro sociale oggi, come ricercatori e formatori insieme ad assistenti sociali e educatori, anche loro nelle loro vesti di ricercatori e formatori artigiani, che cercano di ereditare un modo di fare lavoro sociale senza essere messi nelle migliori condizioni per farlo, senza essere già giunti ad un nuovo punto di ripartenza, ma piuttosto nella fase in cui si procede a scatti, per movimenti scomposti. E come loro anche altri professionisti che lavorano nello stesso ambito. Forse è bene cominciare ad interrogarsi su una crisi che è già “oltre”, come ha detto Ivo Lizzola recentemente, alla presentazione del libro di Franca Olivetti Manoukian Oltre la crisi (Guerini e associati 2015): siamo in “Esodo”, in pieno deserto. Qualcuno cerca oasi e le trova, qualcuno rischia di restare indietro senza bussola e senza molte indicazioni sulla strada percorribile. Ma la traversata è possibile, c’è tanto bisogno di nutrire uno sguardo da ricercatori e fare continui rifornimenti di conoscenza. Alzare la testa e cercare la strada anche guardando in alto, perché alla prima folata di vento le orme nel deserto si cancellano.
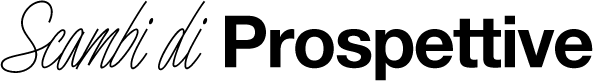
Mi complimento per la scelta dell’argomento, trattato con molta sensibilità e competenza. L’articolo descrive la realtà attuale dei giovani operatori sociali, ma anche dei meno giovani, alle soglie dei 40 anni, che non sono pochi, e che sono ancora nel limbo del precariato. Per la categoria degli educatori professionali la faccenda è anche più delicata, perché non avendo un albo e un Ordine Professionale a cui iscriversi, come è d’obbilgo per gli assistenti sociali, psicologi, ecc., sono meno tutelati, e per questa ragione molte cooperative sociali assumono come educatori altri professionisti (assistenti sociali, ecc.). Ripropongo due articoli da me scritti proprio su Scambi di prospettive, che secondo me, si allacciano all’articolo della dott.ssa Cicoletti:
http://scambi.prospettivesocialiesanitarie.it/i-tagli-al-welfare-ai-tempi-della-crisi-economica-e-tempo-di-ribassi-concorrenziali-sul-costo-del-lavoro-sociale/
http://scambi.prospettivesocialiesanitarie.it/piovono-mucche/
Grazie Davide! Continuiamo a parlarne, scriverne, pensare… C’è un gran bisogno…
Mi sono laureata nel 2009, quindi abbastanza recentemente da ricordare come si sente una neolaureata… Al di là degli aspetti contrattuali e di precariato, la cosa che ho più sofferto è stata la solitudine professionale, il sentirsi un “ragazzo del ’99” mandato in prima linea senza tanti pensieri. Mi piacerebbe che chi si occupa di formazione creasse spazi di trasmissione del saper fare, botteghe dove apprendere ad essere bravi artigiani imparando da chi è più bravo, luoghi in cui confrontarsi a partire dai problemi incontrati sul campo.