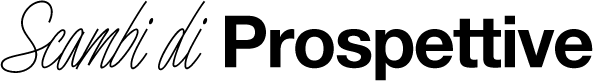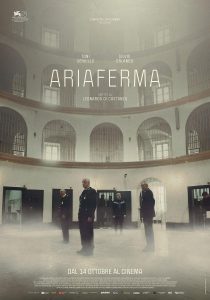Considerazioni sul film “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo, 2021
di Cristina Sironi*
Che cosa mi aspettavo da un film che si svolge in un carcere in dismissione, in stato di abbandono? Non mi ero fatta un’idea precisa, ma speravo in qualcosa di buono, anche solo per andare oltre le denunce che da anni regolarmente riempiono le pagine dei giornali, senza che mai nulla di significativo accada veramente per migliorare la situazione disastrosa e incivile delle nostre carceri. Bene, invece ne sono uscita entusiasta: il film è bellissimo, ricco, intenso, con molti spunti su cui riflettere e ragionare, tanto che vorrei tornare a vederlo ancora.
La trama è questa: un carcere vecchio e degradato sta per essere definitivamente evacuato, i suoi detenuti trasferiti, le guardie restituite per qualche giorno alle famiglie con i loro cari quando, un improvviso e imprecisato cavillo burocratico costringe i dodici restanti carcerati a permanere nella vecchia struttura, e con loro un manipolo di agenti. Da questo momento comincia una sorta di metafisica sospensione, sia nel tempo sia nello spazio che ricorda l’Aspettando Godot di beckettiana memoria (nessuno sa quando il trasferimento si potrà fare, né può accelerarlo) e il Deserto dei Tartari di Buzzati (l’emarginazione dalla comunità umana esterna è palese). Tutto è ancora più incerto e precario di prima: le visite e i colloqui sono sospesi, le attività annullate, il vitto portato da fuori.
La tensione sale, è palpabile, la desolazione di ciascuno dei due gruppi umani – detenuti e guardie – è percepibile, resa da una fotografia livida e opaca che inquieta. Insomma, la situazione si fa pericolosa. L’arrivo di un cibo scadente e immangiabile scatena la rivolta: è sciopero della fame. Non a caso, il cibo, in qualsiasi istituzione, è un indicatore simbolico primario per misurare il clima e il gradimento al proprio interno, perché racchiude anima e corpo, bisogni materiali e spirituali di tutti noi. Quindi il suo rifiuto è un messaggio chiaro.
A questo punto il gruppo delle guardie potrebbe seguire le procedure, fare rapporto ai superiori e gestire la buriana con la forza del potere delle regole, ma l’ispettore Gaetano Gargiulo, non sceglie questa strada: da vero leader del gruppo, si assume la responsabilità di sperimentare qualcosa di nuovo, di aprirsi a una diversa possibilità. Decide di aspettare e dare ascolto alle istanze dei detenuti, con prudenza, senza venir meno al suo ruolo, senza deviare dal suo compito di mantenere l’ordine, con disciplina e rigore. Gli altri suoi colleghi lo seguono, più per rispetto della gerarchia che per convinzione, ma con cameratismo e onestà.
Avviene così che l’ispettore capo prende in considerazione l’offerta di Carmine La Gioia, un boss camorrista a fine pena, acuto e lucido, che vuole effettivamente trovare soluzioni, non sobillare, e che propone di cucinare per tutti. L’ispettore Gargiulo, verificata la fattibilità della proposta, si farà lui stesso garante della sicurezza della pratica. Da questa presa di responsabilità, da questo rischio, si innesca quel cambiamento lento, contagioso, inarrestabile che pervade tutta la storia e ne trasforma i personaggi, pur senza mutarne le collocazioni, rinnovandosi a ogni nuova emergenza che si presenta: il black out elettrico, la fine delle scorte… Ciò trasformerà, di conseguenza, anche le relazioni personali tra i singoli di entrambi i gruppi, a conferma che il rispetto, il prendersi cura, l’inclusione e la condivisione portano alla distensione e anche alla gioia, come nella bellissima scena della cena al lume delle lampade, dove le parole corrono sincere e leggere come le piume dell’angelo nel racconto di un detenuto.
Alla fine del film la tensione che si percepiva nitidamente all’inizio sfuma, si scioglie e al suo posto compare un senso di inclusività, di riconoscimento dell’altro che viene reso dall’inquadratura dei due leader di spalle: l’ispettore e il boss che camminano fianco a fianco di ritorno dall’orto inselvatichito per l’abbandono, ma ancora generoso di erbe commestibili, e si raccontano le loro così differenti vite.
La condizione che permette tutto questo è una sorta di curiosità e attenzione per le persone, una apertura alla dimensione umana di ciascuno, anche del più reietto, senza eliminare le differenze o annullare i reati. Lo sguardo dell’ispettore sa cogliere fin dall’inizio le sfumature emotive di ciascun detenuto, come per il giovane Fantaccini, particolarmente fragile, che viene messo in cella da solo per lasciarlo più tranquillo. (E anche questo prendersi cura sarà contagioso: pure il boss prenderà a benvolere il ragazzo e alla fine tutti lo sosterranno nella sua sventurata vicenda). Con l’emergenza della sospensione questo sguardo umano diventa più consapevole, si fa spazio di elaborazione e di sperimentazione di strategie, diventa regia accurata e rigorosa al servizio dello sviluppo di tutti, pur con l’attenzione a non commettere errori (Gargiulo si rifiuta infatti di bere il vino offerto nella cena condivisa, perché è in servizio!). Alla fine può guardare soddisfatto il frutto del suo lavoro, fatto da un solido intreccio di competenze professionali, scelte etiche e la visione di una società diversa.
Ci immaginiamo che alla lunga il lavoro di guardia carceraria possa diventare alienante, soprattutto se costruito sul meccanismo del rispetto rigido, e spesso insensato, delle regole, e conduca inevitabilmente all’indifferenza verso il variegato campionario di umanità con cui si ha a che fare, a meno che non venga attraversato dalla curiosità per l’umano, dal guizzare empatico del pensiero, dall’interrogarsi su cosa si può tentare e che cosa no.
Certo, il cambiamento non è un processo lineare, ma un work in progress sperimentale, che va pensato, coltivato e gestito con tanti rischi e molta fatica, attraverso una coralità di sfumature comunicative e di alleanze, ma alla fine può davvero portare a risultati relazionali connotati da grande dignità umana.
I due attori che si fronteggiano nel film, Toni Servillo e Silvio Orlando sono campioni di bravura, in una continua schermaglia fatta di sguardi, silenzi e parole misurate, in una recitazione per sottrazione dove le emozioni sono forti, ma invisibili e compresse, definite da gesti minimi eppure efficaci. La musica, altrettanto severa ed essenziale, accompagna con misura le vicende.
Alla fine sento sorgere una domanda senza riuscire a rispondermi: perché nella detenzione anche del peggior delinquente, invece di cercare la strada per far emergere qualcosa della sua umanità, sembra così necessario l’isolamento che – lo vediamo- finisce con incattivirlo?
*educatrice e formatrice