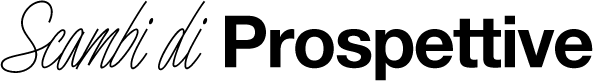di Debora Rota*
 Tutto comincia quando il Presidente della mia Cooperativa mi dice che apriremo una Residenza Sanitaria per persone Disabili …
Tutto comincia quando il Presidente della mia Cooperativa mi dice che apriremo una Residenza Sanitaria per persone Disabili …
Lavorando da tempo per la Cooperativa C.R.M. di Milano, in quel momento come coordinatrice di una struttura diurna per disabili, mi sentivo, un po’ presuntuosamente, di conoscere bene “la materia” di cui stavamo parlando e così ho accettato di buon grado di inoltrarmi in questa avventura.
Partono da subito colloqui con il personale da assumere, colloqui con le assistenti sociale dei Comuni alla ricerca di strutture per i propri residenti disabili in condizione di necessità, colloqui con le famiglie che ancora stanno facendo i conti con “l’inevitabile destino” di dover, il più tardi possibile, abdicare dal potere assoluto di badare ai propri figli in favore di “residenze altre”, con famiglie che desiderano capire di che “nuova casa” stiamo parlando.
La preparazione che sta dietro all’apertura di una struttura non è cosa da poco e ripensando ad allora mi ricordo che mi dicevo “non abbiamo ancora aperto i battenti ed ho l’impressione che tutte queste parole possono essere spese meglio. “Spese”, forse scambiate, darne per riceverne, e soprattutto “sentirle” per provare a trovare insieme un significato che possa avere un senso, o che sia quantomeno soddisfacente per tutti ”.
Era già chiaro che mi trovavo di fronte ad una situazione lavorativa differente, che il prendersi cura di persone che ti venivano affidate dalle famiglie per qualche ora al giorno non era neanche per metà paragonabile al senso di smarrimento o all’angoscia o alla, perché no, diffidenza di chi doveva obtorto collo “mollare” il potere decisionale sulla cura/vita del proprio parente.
Si, “mollare”, perché il sentimento che sentivo nelle parole, negli sguardi delle mamme, dei papà, delle sorelle o fratelli aveva quel sapore di perdita mista a sconfitta, come una squadra che non potendo più decidere sulla campagna acquisti per la futura stagione si sente già perdente, senza neanche aver giocato la prima di campionato.
Allora ho iniziato a sentire che agli strumenti del mio mestiere serviva un po’ di manutenzione e che, a conti fatti, avrei dovuto anche fare una ricerca di mercato per acquistarne di altri, per giunta, di nuova generazione.
Sono approdata così al Corso triennale di Counselling Professionale Sistemico-Relazionale del Centro Milanese di Terapia della Famiglia (CMTF).
L’intento era quello di acquisire competenze in più da spendere nel mio lavoro, “andare a scuola” a seguire le lezioni e studiare delle nuove materie, ma subito mi sono resa conto con non era così, o meglio, non era solo quello.
Certamente non si può prescindere dall’imparare che esistono dei punti fermi, degli ‘assiomi’ sulla comunicazione che ci guidano all’approccio con l’universo del comunicare e dell’entrare in relazione con gli altri.
Ma nella cassetta degli attrezzi ci è entrato molto di più.
La consapevolezza che in qualsiasi relazione quello che avviene ‘al di sotto delle parole’ è uno scambiarsi di messaggi con gli occhi, con il tono della voce, con la postura del corpo, perfino con i colori con cui scegliamo di vestirci. Tutto ciò influenza come stiamo in relazione con l’altro e ci accompagna nella nostra, più o meno inconsapevole, interazione tra pre-giudizi.
Si, pre-giudizi, ‘giudizi a priori’ che diventano idee sull’altro, la persona in relazione con noi, idee che se non tenute ben presenti rischiano di appiattire quella ‘curiosità sistemica’ che ci fa sentire, insieme al nostro interlocutore, come ‘ricercatori di senso’.
Se pensiamo alle relazioni con gli ospiti della residenza, con le loro famiglie, ma anche con gli operatori che con le loro diverse professionalità vi lavorano, diventa importante esserci con l’ottica di co-costruire una storia.
Una storia di lavoro, di cura, di vita, che non può prescindere dalla convinzione che ognuno è portatore di risorse e di punti di vista, e che questi trovano senso ed efficacia solo se non escludono quelli degli altri, anzi, se vi si aggiungono.
Con queste lenti la residenza allora sembra apparire un ‘sistema’ di relazioni complesso, che mette in connessione tutti quelli che ‘esistono’ lì dentro o che entrano ed escono continuamente dal sistema.
Balza subito all’occhio che l’incontro tra i diversi sottosistemi pone la questione dell’incontro tra le richieste e le esigenze di ogni parte, operatore, famiglia, ospite e gruppo che sia, e che le stesse si scontrino con i limiti e le inevitabili restrizioni che i sistemi organizzati impongono.
Ecco che nella cassetta degli attrezzi ci è entrata anche l’idea che avere lo spazio per poter lavorare sull’ascolto reciproco, sull’attribuzione di senso alle diverse ipotesi e alle diverse proposte, sulla sospensione del giudizio e sospensione delle modalità comunicative finalizzate a sostenere le proprie ragioni o a convincere gli altri, possa rivelarsi uno spazio di intervento che, in qualche modo, cerchi di rispondere a quelle difficoltà.
Se pensiamo alle famiglie, creare ambiti stabili di incontro e di comunicazione permette, o comunque facilita, la co-costruzione del progetto di cura: gli incontri diventano il momento delicato ma ghiotto per affrontare non solo momenti specifici di difficoltà ma in generale rispondono alle necessità di ricevere comprensione profonda, ma non passiva, delle vicende familiari, in rapporto alla disabilità del loro parente o alla vita di coppia dei genitori.
Se pensiamo agli operatori dobbiamo invece partire dall’idea che il momento più importante di scambio tra l’operatore (sia esso asa, fisioterapista, infermiere od educatore) e l’ospite è nella relazione tra loro, e che le specifiche attività diventano lo strumento con cui si entra in relazione.
In questi momenti la capacità discrezionale soprattutto di alcune figure professionali viene messa alla prova continuamente e in termini reali: avere uno spazio in cui attraverso le parole ed il racconto si riflette sul proprio operato, diventa un processo in cui mentre si impara ad osservarsi, si impara anche ad osservare l’altro e, mentre si impara, si ‘impara anche ad imparare’.
Ma noi siamo persone, che lavorano e hanno anche altri pezzi di vita.
Più di una volta mi sono trovata a domandarmi come mai mi capitava di parlare con le persone di cose che non sembravano attinenti al contesto lavorativo e mi domandavo anche se ne valesse la pena dedicare tutto quel tempo a parlare di empasse di tipo personale.
Mi capitava e mi capita spessissimo …
Ecco che dalla cassetta ora posso attingere ad un’altra idea: l’idea che il benessere personale sostenga ed influenzi il benessere professionale e viceversa, l’idea che il benessere dell’operatore promuove la necessità essenziale dello sguardo su di sé, ed ancora l’idea che l’incontro tra il possibile ed il desiderabile sfoci in una scelta creativa che soddisfi il benessere della persona e delle persone coinvolte nel sistema.
Allora penso alla mia professione di “aiuto” e a tutte quelle che richiedono un rapporto tra e con le persone, ed una idea, dopo questi tre anni di corso di Counselling a modello Sistemico-Relazionale al CMTF, è diventata irrinunciabile.
Non posso più nascondere che le abilità di counselling intese non solo come tecniche comunicative ma anche come ‘atteggiamento relazionale’ le sento addosso come un vestito cucito sulla mia misura.
Le sento come una marcia in più di cui posso usufruire mentre sono alla guida della mia macchina, che si sa, essendo un mezzo di trasporto mi fa spostare, mi fa viaggiare, mi fa muovere più consapevolmente nell’incontro con l’’altro.
* Counsellor e Mediatore Familiare, formatasi al Centro Milanese di Terapia della Famiglia