di Patrizia Taccani
*Non è stato facile decidere di aprire il libro di Camelia Ciuban, credo, già a partire dal titolo: “La belva. Sono una maniaco-depressa e contenta di esserlo” (1) e mi sono domandata che cosa mi avesse momentaneamente allontanata dal desiderio di iniziarne la lettura. Ho capito che l’aggettivo “contenta”, inserito nel sottotitolo, mi suonava come provocazione eccessiva. Del resto in molti punti del suo racconto si è chiamati a raccogliere delle sfide. Ci imbattiamo in parole forti, in minuziose descrizioni di vissuti intimi, personalissimi, ci affacciamo su vuoti che fanno trattenere il fiato. Non è mai una sfida respingente però, così come non ci si troverà mai di fronte a richiesta di compatimento. Occorre leggere attentamente riga dopo riga, ma soprattutto accettare di ricomporre frammenti di un’esistenza accompagnati, nel racconto, all’alternarsi di emozioni e pensieri a volte totalmente in contrasto tra loro. Bisogna accettare di ascoltare la malattia mentale vista solo dal di dentro di chi la vive, non mediata dagli specialisti.
Torno allora al titolo: contenta. Contenta di che cosa? A me è sembrato che Camelia Ciuban abbia trovato una primissima apertura nella sua non facile storia di malattia quando – con impegno, studio, letture accompagnate da una prima diagnosi medica – ha iniziato a diradare il fumo intorno al suo disturbo mentale, anzi quando ha potuto dargli un nome. “Fu abbastanza facile ammettere di soffrire di attacchi depressivi […] Capire di soffrire di una malattia psichiatrica non basta per migliorare, non è che l’inizio di un percorso in cui si può restare bloccati se non viene superata la tendenza ad acconsentire al disturbo di farsi luogo in te, cioè a compiacersi nella malattia.” In realtà Camelia proprio sulla diagnosi, per diversi anni resta in una condizione di sospensione: parziale consapevolezza, la definisce. L’Autrice vive in “una Romania ridotta alla miseria da Ceausescu” dove, dirà più avanti, non ebbe a soffrire la fame ma certo non si saziò mai di fragole… Frequenta il liceo e intanto lavora in fabbrica, successivamente finisce l’Università e si laurea, appena dopo la caduta del regime. Una dopo l’altra vince molte scommesse che aveva fatto con se stessa. Ma continua a incontrare dolore dopo dolore, ogni volta quel dolore “ è il più grande del mondo”. A poco più di trent’ anni ha già cercato due volte di togliersi la vita. Quando accade per la seconda volta è già in Italia. E’ sorprendente come sia chiara e piana la scrittura attraverso cui arriva al lettore il suo vissuto di persona che cerca di morire. Tutto il contrario di quel che siamo soliti pensare. Infatti scrive che il pensiero della vita come appiglio per sfuggire al suicidio in lei diventava “deflagrazione e caos. […] Mi aggrappavo poi di nuovo al pensiero della morte e tornavo a respirare. Tregua, riposo.” Viene salvata da chi, come scrive in nota, “sarebbe diventato da lì a poco mio marito e il papà del mio bambino.” Non siamo però al lieto fine, alla chiusura della storia. Permane, ad esempio, la necessità di non dimenticare il capitolo dei passati ricoveri, delle terapie inefficaci quando non dannose, delle conseguenze subite a causa dell’incompetenza, o per lo meno dalla approssimazione, con cui servizi, medici, psicoterapeuti hanno diagnosticato e quindi trattato la sua malattia: ne ripercorre così le tappe. Sembra paradossale, ma la luce in fondo al tunnel inizia a vedersi quando arriva la nuova diagnosi – non leggera – formulata dall’ennesima psicoterapeuta cui Camelia si è affidata: disturbo affettivo bi-polare, malattia maniaco-depressiva. “Finalmente il male aveva un nome, il nemico un volto ed io un’urgenza incontenibile di capire.”.
Il racconto della vita di Camelia Ciuban prosegue
Dopo aver letto il breve dialogo tra lei e la psicoterapeuta ed essermi imbattuta in quel disvelamento che si è palesato sin da subito colmo di promesse, torno al sottotitolo del libro. “Sono una maniaco-depressa contenta di esserlo”. A questo punto le parole non suonano più come provocatorie. Camelia è stata ascoltata sino in fondo e presa in carico da una terapeuta che alla competenza professionale unisce una gamma di qualità umane difficili da trovare in un’unica persona: materne, paterne, sacerdotali, amicali. E che, accanto alla passione per il proprio lavoro, mostra “il pudore di chi è abbastanza umile per ammettere che non ha una risposta a tutto.” Anche se poi, nell’accompagnamento, fornirà indicazioni preziosamente efficaci. Per Camelia Ciuban le radici di un sollievo che porta sino alla chiara ammissione della propria malattia e ad una buona gestione di questa possono impiantarsi, effettivamente, solo nella verità. Anche se non basta – occorre un lungo lavoro di mente e di cuore – tuttavia il terreno è quello.
Nel libro “Le emozioni ferite” (2), Eugenio Borgna, da psichiatra e psicoterapeuta, invita esplicitamente ad andare alla ricerca delle emozioni perdute: quelle di chi cura e quelle di chi della cura ha bisogno. Le emozioni che gridano, quelle che si smorzano e si fanno impalpabili, quelle che affondano nelle notti dell’anima. Camelia Ciuban, nel suo libro, prima le ha fatte diventare oggetto di un doloroso, a volte implacabile, ascolto interiore. Poi le ha fatte sgorgare, trasformate in parole che infine, lucidamente, ci consegna.
(1) Il volume si può richiedere a di*************@li****.it oppure direttamente allca*****@in****.it“>’Autrice. Il testo è disponibile anche in formato e-book.
(2) Borgna E. (2009), Le emozioni ferite, Feltrinelli, Milano.
* Psicologa, formatrice, redattrice di Prospettive Sociali e Sanitarie
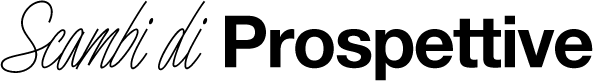

Ho trovato molto interessante l’articolo di Patrizia Taccani circa il libro di Camelia Ciuban. Ho alle spalle (almeno mi auguro, visto che l’ultimo episodio depressivo risale al 2003) una “ventennale e brillante carriera depressiva”, con dei picchi nel mese di maggio – quando la luce aumenta. Anch’io ho incontrato, soprattutto all’inizio, inadempienze, approssimazioni e molto altro ma a differenza di Camelia non sono mai riuscita a scrivere circa la mia esperienza depressiva, pur amando la scrittura ed avendo scritto qualche
libro. Non mi sento ad oggi “guarita” proprio perchè non riesco a scrivere quei 20 anni di malattia, che tra quelle da me vissute, è stata decisamente la peggiore.Brava Camelia