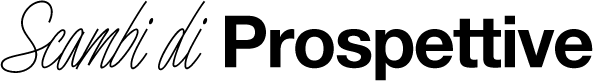di Mattias Bassotto*
di Mattias Bassotto*
Questo breve intervento vuole promuovere una riflessione sul lessico usato da chi opera nel sociale, perché le parole usate dal professionista contribuiscono a restituirne l’immagine e a costruire la relazione con chi accede ai servizi.
Nelle professioni sociali la dimensione relazionale-interpersonale è costante (Blandino, 2004) e uno degli strumenti che noi operatori abbiamo a disposizione per costruire la relazione con l’altro è il linguaggio verbale. Allegri, Palmieri e Zucca (2006) ritengono che porre attenzione al canale linguistico della persona (alle sue metafore, ai suoi modi di dire e alle parole usate) ci aiuta a esplorare la sua realtà soggettiva e a meglio comprendere il problema portato. Se questo è vero nella direzione professionista – utente, lo è anche in quella inversa. Con il presente scritto, intendo riflettere sulla centralità del lessico utilizzato dal lavoratore sociale, perché le parole usate e i modi di dire contribuiscono a dare l’immagine del professionista (e conseguentemente del servizio che rappresenta) e possono aiutare a diminuire il rapporto di subalternità percepito inevitabilmente da chi accede ai servizi.
Lessico e processo comunicativo
Giudice e Ritorto (2022, p.136) ci ricordano quanto sia importante la percezione dell’altro in una comunicazione efficace. Affermano, infatti, che “le parole costituiscono la voce del cervello poiché esprimono pensieri, emozioni, opinioni e giudizi. Esse, però, (…) fanno molto di più: incidono, infatti, sulla percezione del contesto e del mondo”. Nei servizi accade spesso di ignorare il ruolo significativo del lessico nel processo comunicativo, e di dare per scontato che l’interlocutore abbia compreso quanto gli stiamo dicendo solo per il fatto di averglielo comunicato e, se non ha compreso, attribuirgli la colpa.
Ammettiamolo, quante volte abbiamo detto o sentito nei servizi che abitiamo:
“Non ha capito niente”, “Gliel’ho detto mille volte e continua ancora a rompere”, “Continua a chiamare per chiedermi la stessa cosa”, “Ha rotto i c…”.
Tenuto conto necessariamente di alcuni tratti di personalità su cui ben poco possiamo essere incisivi, quanto volte ci siamo fermati a pensare sulla responsabilità del lessico che utilizziamo nella decodificazione errata del contenuto di un messaggio nell’ambito del processo comunicativo?
Appare utile tenere viva una riflessione non solo sul nostro stile di comunicazione, ma soprattutto sulle parole che utilizziamo: dopotutto, se non siamo consapevoli del nostro stile e del nostro linguaggio, come possiamo definirci competenti nell’ascoltare e interpretare quello dell’altro?
Linguaggio operativo e costruzione della relazione d’aiuto
“Quando l’assistente sociale del Comune mi ha chiesto se ero in carico ad altri servizi, io sono rimasto… In carico? Mi sono sentito un peso, un carico sulle spalle… Non sono più tornato»
Queste sono le parole di G., conservate in modo indelebile nella mia memoria, ascoltate durante un colloquio finalizzato a presentare richiesta di assistenza economica. In quel momento, nei miei due ruoli di professionista e di persona, ho compreso quanto importante fosse l’uso delle parole nel mio lavoro (e nella vita).
Era un signore ultra-sessantenne, che aveva lavorato per anni, e che all’improvviso si era trovato senza occupazione a pochi anni dalla pensione. Scarsa rete familiare, basso livello di scolarizzazione, casa in affitto, una storia di vita articolata e difficile: tirava avanti con piccoli lavori in nero, il Reddito di cittadinanza e qualche sussidio del servizio sociale. Una storia unica, ma simile ad altre storie, che ordinate insieme vanno a costituire fenomeni sociali che ben conosciamo nei servizi territoriali: disoccupazione, povertà, difficoltà di rientro nel mercato del lavoro, isolamento.
Secondo Gheno, 2019 (pp. 12-13), una delle tre funzioni principali di una lingua, oltre a definire sé stessi e a comunicare con gli altri, è descrivere il mondo: «Il modo in cui chiamiamo le cose non è indifferente, dato che ne metterà in luce aspetti diversi. Perché esistono i sinonimi per esempio? Perché non inventare un sistema semplificato in cui a ogni cosa o concetto corrisponde uno e un solo cartellino? Non sarebbe tutto più semplice? Certo; solo che perderemmo molte possibilità espressive: ognuno di noi ha, invece, modo di dire con parole sue quello che percepisce della realtà».
L’esperienza avuta con G. mi ha insegnato che la cura del nostro linguaggio operativo influisce sulla costruzione della relazione di fiducia e aiuto tra la persona e i servizi. Le parole veicolano messaggi, percezioni della realtà: il termine “carico” può rimandare a qualcosa di pesante, poco gradito sulle spalle, come G. mi ha riportato. Pensiamo a come sia nei colloqui, sia negli scritti, possa essere preferibile usare frasi come “è conosciuto dal servizio” oppure “in un percorso di accompagnamento”. Tali espressioni possono aiutare a definire una relazione d’aiuto più simmetrica e a sostenere la costruzione di un clima più disteso nei colloqui.
Giudice e Ritorto (2022), riferendosi a una scrittura efficace, invitano a evitare il “burocratese” e i tecnicismi, che hanno come unico effetto quello di farci allontanare dai destinatari dei nostri scritti. In parallelo, potremmo affermare che lo stesso vale per i colloqui e le parole che scegliamo di usare come professionisti. Utilizzare con le persone il termine “carico” per parlare del loro accesso ai servizi va a evidenziare il rapporto di potere – squilibrato – tra loro e il professionista, rimandando a una concezione che le vede come pesi del sistema sociale e non come fruitrici di diritti acquisti. Per contro, una persona che “conosce” o “beneficia” di un servizio mi appare più in linea con un approccio al lavoro sociale in grado di restituire dignità e rispetto alle persone, riconoscendole come soggetti attivi fruitori di servizi che spettano loro in un sistema di welfare.
Il socialese: un linguaggio burocatrico-giudicante
«Com’è che le chiamate voi? Criticità? Ahahah»
Una collega del servizio di psicologia e io eravamo in colloquio con il sig. D., genitore seguito da molti anni dal servizio sociale. Separazione, luoghi neutri, sostegno alla genitorialità: un percorso che stava evolvendo verso un graduale recupero e incremento del tempo padre-figli. Noi insistevamo sulla necessità di proteggere i minori da scene di conflitto durante gli scambi dei bambini tra i genitori, prima di immaginare un’evoluzione della situazione.
Quando il signore durante il colloquio ha pronunciato la frase riportata sopra, mi sembrava ci facesse il verso; e da allora, “criticità” mi appare il classico termine “socialese”, ridondante, che rischia di farci allontanare dall’interlocutore.
Ritengo che il termine “preoccupazione” possa aiutarci a spostare la conversazione su un terreno emozionale, più che burocratico-giudicante, sostenendo una sintonizzazione con chi ci sta davanti, e che la frase “cose che si possono migliorare” possa aiutare chi ci ascolta (e noi) a focalizzarci sulle risorse, piuttosto che sulle mancanze.
Squilibri di potere
«Scusi se ci siamo dilungati, le abbiamo fatto perdere tempo» «Scusi se l’ho disturbata»
Nei colloqui ho sentito molte volte la parola “disturbo” usata dai miei interlocutori. Un termine che, a mio parere, riproduce e accentua lo squilibrio di potere (di cui parla chiaramente Fargion, 2013) esistente tra il professionista e la persona. Come argomenta Murgia (2021), in Stai Zitta, e altre nove frasi che non vogliamo sentire più, il linguaggio è un’infrastruttura culturale che riproduce rapporti di potere. Tale considerazione, che nel libro di Murgia si attesta sulla questione femminista, è preziosa anche per il nostro ambito di riflessione.
Chi fruisce di un servizio spesso sente di disturbare i suoi operatori, sempre oberati di cose da fare. Esplicitare il fatto che il nostro tempo, in quello spazio, è dedicato a chi ci ascolta, dà valore al colloquio e al nostro lavoro di professionisti al loro servizio (dopotutto, se lavoriamo nel pubblico, significa che siamo pagati con le tasse della collettività, e lavorare non dovrebbe essere un disturbo!).
Riflessione e curiosità
In conclusione, gli stimoli proposti in questo contributo hanno la finalità di tenere viva una riflessione sull’uso della lingua nel lavoro sociale, fondamentale perché le parole sono uno degli strumenti principali che abbiamo a disposizione in una professionalità relazionale, che ci richiede “la capacità di svilupparsi e cambiare, sottoponendo a riflessione e confronto continuo sia quello che vien fatto, sia soprattutto, come viene fatto” (Blandino, 2004). La capacità di lavorare in relazione con l’altro può crescere e migliorare solo se costantemente analizzata e sottoposta a riflessione. Il rischio di non farlo è quello di perpetuare le routine burocratiche e i loro linguaggi scarsamente accessibili alla collettività.
“Parola chiave: curiosità o (forse meglio) cura”: una bella sollecitazione, fra le altre, contenuta in Potere alle parole, Perché usarle meglio (2019), della sociolinguista Vera Gheno, che ci ricorda: «Ognuno di noi è le parole che sceglie: conoscerne il significato e saperle usare nel modo giusto e al momento giusto ci dà un potere enorme, forse il più grande di tutti». L’esperienza lavorativa quotidiana con le persone lo conferma.
Bibliografia
- Allegri E., Palmieri P., Zucca F., 2006, Il colloquio nel servizio sociale. Carocci, Roma.
- Blandino G., 2004, “La formazione degli operatori. Come sviluppare le capacità relazionali”. In Compendio di psicologia, a cura di A. Imbasciati, M. Margiotta. Piccin, Padova.
- Fargion S., 2013, Il metodo del servizio sociale. Riflessioni, casi e ricerche. Carocci Faber, Roma.
- Gheno V., 2019, Potere alle parole, Perché usarle meglio. Giulio Einaudi, Torino.
- Giudice E., Ritorto S., 2022, La gestione del conflitto. Manuale per operatori sociali, mediatori e avvocati. Carocci, Roma.
- Murgia M., 2021, Stai Zitta, e altre nove frasi che non vogliamo sentire più. Giulio Einaudi, Torino.
*Dottore magistrale in Lavoro, Cittadinanza Sociale, Interculturalità presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia; assistente sociale presso il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese (TO); formatore.