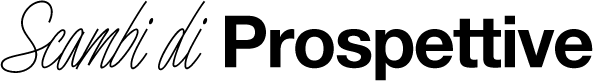Spesso capita di andare al cinema a vedere un film tratto da un libro (generalmente preferiamo il libro). In questo caso invece si tratta di un film che precede il testo, scritto successivamente. Stiamo parlando di “Tra 5 minuti in scena” del 2013 (ora anche in DVD, vedi anche post su Scambi di Prospettive) di Laura Chiossone, regista di corti e di “Mamma a carico” (Einaudi, 2015) di Gianna Coletti, attrice, ispiratrice del film, oltre che autrice del libro.
La strana genesi è degna di nota perché ci mostra come un iniziale interesse della regista alla situazione individuale dell’attrice, sia stata prima raccontata attraverso le immagini e approfondita e scandagliata poi attraverso le parole. Immagini e parole che si integrano e si completano senza alcuna ridondanza, ma anche in totale autonomia le une dalle altre e che aiutano lo spettatore e il lettore a capire meglio come può declinarsi il complesso rapporto d’amore tra una madre e sua figlia, quando intervengono malattia e vecchiaia a scombinare le carte e a capovolgere i ruoli. Si tratta infatti di una storia di quotidiana attualità: quella del rapporto di Gianna, attrice di mezza età alle prese con la precarietà e le incertezze della vita, con la madre Anna novantenne, non più autosufficiente, cieca, che “porta occhiali 3D perché è abituata da sempre ad avere qualcosa sul naso”, costretta su una poltrona, con la testa che “ogni tanto va per conto suo”. Una madre, lo si avverte subito, dal carattere ribelle, anarcoide e piuttosto volitiva: non ama affatto che ci sia “qualcuno a decidere per lei, anche se è sua figlia” e che si rivolge al mondo con un’ “ironia graffiante e un grande cuore un po’ egoista”.
I temi che attraversano le due narrazioni sono quelli dell’invecchiamento, della malattia, del corpo fragile e vulnerabile fino all’immobilità, della mente debole che dà segnali intermittenti che creano paure, del senso di impotenza che coglie chi cura e assiste, degli spazi di vita che si riducono, della prossimità della fine … Certo temi non facili, poco accattivanti, ma è intenzione delle autrici non fingere o chiudere gli occhi di fronte alla durezza della vecchiaia e arrivare al cuore della questione: quando il tempo che resta è poco, deve avere un senso. E qui si gioca la scommessa delle autrici: mostrare la bellezza di una relazione complessa e generativa come quella tra madre e figlia, fatta di contrasti e complicità, sacrifici e dedizioni che raggiunge un punto di schiettezza, di verità, che soddisfa entrambe. Anna e Gianna sanno dirsi cose ‘scomode’, si fronteggiano sempre, con ironia e leggiadria fino a farci sorridere, riuscendo a fare l’una per l’altra quanto non avrebbero fatto per se stesse.
Il film è strutturato su diversi piani di narrazione che si intersecano e a volte paiono confondersi. Racconta la vicenda di una compagnia di attori – dai precari finanziamenti, incerti fino alla fine – che sta per mettere in scena un testo speculare alla vicenda dell’attrice Gianna: una madre anziana, non più in grado di vivere da sola (malgrado la supervisione ansiosa della figlia e di una compiacente e isterica vicina di casa) e che deve accettare l’arrivo di una badante. E non certo a cuor leggero! Dunque un passaggio esistenziale delicatissimo sia per la madre (perdere la propria autonomia e dipendere da una forestiera!) sia per la figlia (delegare la cura della madre a un’estranea, con sensi di colpa e incertezze infinite), che genera controverse e ambivalenti reazioni. Contestualmente nel film è raccontata la vicenda vera dell’attrice con la madre, inferma e cieca, che non manca di far battute argute che spiazzano l’intera troupe che sta girando, quasi fosse un’attrice consumata … sullo sfondo di una Milano marginale, poco conosciuta, antica, quieta e silenziosa. Un film dove realtà e finzione spesso si mescolano fino a confondersi, come in un gioco di scatole cinesi: perciò l’uso del bianco e nero indica la rappresentazione teatrale, dove i toni farseschi, drammatici e comici dei personaggi protagonisti danno movimento e spessore, leggerezza e sostanza a temi delicati e scottanti che lasciano nello spettatore, anziché il peso della drammaticità delle situazioni (la perdita di autonomia, la responsabilità verso gli altri, le difficoltà quotidiane della vita, il peso della solitudine), la consapevolezza che, con una dose di ironia e di disincanto, si riescono ad attraversare anche le situazioni più claustrofobiche. Il film è coraggioso, corale, amaro, con momenti di tenerezza: mette a nudo la vita nella sua fragile prosaica quotidianità, senza infingimenti, con le difficoltà e i bisogni di amore, attenzione, riconoscimento, sicurezza, di ciascuno dei protagonisti, nella precarietà dell’esistenza. L’alternanza dei piani tra rappresentazione teatrale, vita vera e finzione filmica, rimanda, come in una galleria di specchi, all’umano arrabattarsi per riuscire a stare al mondo in un modo dignitoso e responsabile, in grado di trovare soluzioni umane e generose, superando i propri egoistici interessi.
Il libro, scritto dopo e uscito a due anni dal film, è una riflessione a cuore aperto, in prima persona, di una figlia che si fa madre di sua madre, restituendole in qualche modo quel credito di cura, attenzioni, impegno e aspettative impiegate per farla crescere e intraprendere una carriera artistica. Il sottotitolo: mia figlia ha novant’anni, lo esplica con dovuta ironia. Ma è anche il diario di una figlia che deve capitolare di fronte a una madre che “è una forza della natura”, che “nella vita ha sempre fatto tutto ciò che le passava per la testa, senza pensare alle conseguenze, spinta solo dal suo istinto” e che di conseguenza l’ha “fatta vivere costantemente preoccupata, incazzata e inchiodata al suo volere”. Un rapporto fatto di complicità e solidarietà, di affanni e spensieratezze, di apprensione e allegria, di sfide continue e sensi di colpa. Nell’ascoltare il racconto di Gianna anche noi lettori rimaniamo affascinati da Anna per la sua logica spiazzante, le battute fulminanti e la grintosa voglia di vivere e ci fa simpatia il suo intercalare i disagi quotidiani con il paziente “tiremm innanz” o, più frequentemente, il ruvido “va a dà via i ciapp”, piuttosto che il perentorio “me sun rotta i ball” quando vuol mettere fine a qualcosa che non le piace e avere l’ultima parola. Nello stesso tempo siamo solidali con i dubbi e le fatiche di Gianna che confessa: “non so se con la mia vecchia sono una buona madre; ce la metto tutta ma ho l’impressione di commettere un sacco di errori, pur pensando sempre al suo bene. Sto navigando a vista, spero solo di toccare terra.” E nello stesso tempo riflette sul fatto che “c’è qualcosa di innaturale nel trasformarsi in genitori di un bambino di 90 anni (…): nel mettersi a totale disposizione di un bambino c’è un orizzonte. (…) Quando assisti un vecchio, invece, sai già come andrà a finire.“ E non è una differenza da poco: confrontarsi con la fine della vita fa paura, pone domande senza risposta e costringe a guardare in faccia il proprio invecchiamento … Ma l’autrice non si arrende, è tenace e continua: “bisognerebbe però riuscire a ricordarsi in ogni istante la fortuna di potergli stare accanto, anche nei momenti in cui sembra più difficile farlo. Una fortuna per la nostra vita futura”, rivendicando quindi la positività della sua scelta di accudimento, piuttosto che quella del ricovero in una casa di riposo, da cui in più situazioni appare ripagata, come quando il badante le racconta che alla mattina è sempre di buonumore. Racconta poi che questo ribaltamento di ruoli le ha permesso di conoscere un’altra madre, più affettuosa e garbata, più espansiva: “mi commuovono alcuni suoi piccoli gesti: per esempio quando mi cerca la testa per accarezzarla con una tale delicatezza come se avesse paura di farmi del male, o mi prende la mano per tenerla tra le sue e con un gesto improvviso se la porta alle labbra per baciarla.” Allora, per evitare patetismi, la rimbrotta subito: “mamma, non sono mica il Papa!”, restando nella consuetudine del loro rapporto di botta e risposta senza sconti e false cortesie.
La scrittura è asciutta, agile, schietta, ironica e, paradossalmente, mette allegria perché riesce a coinvolgere il lettore nelle umane debolezze di entrambe, ad avvicinarlo a temi da cui si vorrebbe fuggire a gambe levate se non fossero trattati con disarmante sincerità e onesta ingenuità. Soprattutto resta al lettore la piacevole consapevolezza di una relazione forte, di un radicamento speciale nella vita dell’altro, che è ciò che dà senso alla vita di ciascuno di noi. Si potrebbe concludere con una battuta del libro che fa ben sperare una generazione di cinquantenni con genitori a carico: “Ho una figlia di novant’anni e passa che mi fa ammattire, mi diverte, mi strazia, mi fa piangere. Ma mi fa vivere”.
* animatrice sociale e formatrice