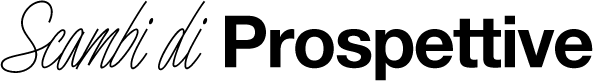Un battesimo professionale ai tempi del Coronavirus
Un battesimo professionale ai tempi del Coronavirus
Scrivere significa riflettere, vuol dire svolgere un esercizio di retroazione (feedback) verso ciò che è stato, una sorta di scambio comunicativo interiore (Simeone 2002).
Ed oggi, nell’odierno caos che esaspera il nostro vivere nella postmoderna società dell’incertezza (Bauman 1999), riflettere diventa fondamentale perché ci consente di fermarci, ossigenare il nostro cervello e ricaricare le batterie psicologiche che ci permettono ancora di stare e muoverci nel mondo come animali sociali imprigionati però nella gabbia di una “quotidianità confinata” all’ambito domestico che ci è richiesta dal “distanziamento sociale forzato” (D’Ambrosio 2020, 1) imposto dagli attuali vincoli normativi emergenziali. Riflettere è sì fondamentale per tutti ma ancor più lo è per chi fa della pratica riflessiva un connotato essenziale e discriminante della propria esperienza professionale: insomma, per gli Assistenti sociali. Per questi ultimi infatti praticare la riflessività significa evitare “risposte standardizzate e routinarie alle situazioni” che ci si trova ad affrontare, significa “fare i conti con la complessità, la mutevolezza e l’incertezza proprie del lavoro con le persone” (Thompson 2006, 301).
Una riflessività interiore è insomma la conditio si ne qua non per lavorare con la materia umana e tuttavia nemmeno questa è sufficiente: per occuparsi delle persone e dei loro bisogni è necessaria quella che Donati chiama “riflessività relazionale”, in quanto “esercitata dai soggetti agenti, non già sui loro pernsieri interiori, ma sulle relazioni sociali e sui loro poteri ed effetti”, “un riflettere sulle/con/dentro le relazioni che i soggetti agenti hanno con gli altri significativi” (Donati 2013, 25).
Relazioni che oggi sono duramente messe alla prova da un virus che ci impone di troncare il nostro stare assieme, di recidere legami sociali già liquidi (Bauman 2012) e deboli.
In una tale condizione che mette a dura prova il nostro essere operatori del sociale e dell’umano, gli esercizi di riflessività interiore e relazionale rappresentano un fondamentale ristoro per chi vuole continuare ad apportare il proprio contributo al benessere sociale anche nell’oggi caotico e confuso del coronavirus, caratterizzato da un forte riemergere di nuove e vecchie solitudini, di stress e smarrimento.
È in tale disarmante contesto che mi sto misurando con il mio battesimo professionale quale Assistente sociale nel servizio sociale di base, nel Comune. L’istituzione per eccellenza “più vicina al cittadino e quindi più capace di comprenderne i bisogni e di programmare risposte adeguate” (Franzoni e Anconelli 2014, 83). L’espressione insomma più piena della centralità del territorio nel sistema integrato di interventi e servizi sociali (secondo la 328/00). È qui, in questa frontiera, che sto “nascendo alla professione”, in un contesto professionale particolarmente prossimo agli utenti e in un’ora nella quale i bisogni dei cittadini tutto d’un tratto si esasperano e si diversificano mentre le risposte rischiano di essere sempre parziali o poco centrate sul problema reale.
Mi trovo in un qui ed ora particolarmente sui generis (nel senso di “fuori dall’ordinario”) e faccio così l’esperienza (seguendo un celebre trittico del servizio sociale (1) dell’utente che si interfaccia per la prima volta con i servizi (l‘ente) portando con sé il suo bagaglio di paure, le sue poche conoscenze e le sue, quasi nulle, esperienze, in un ambiente sociale particolarmente nuovo, incerto (Bauman 1999), rischioso (Beck 2000), liquido (Bauman 2012).
Le sfide che mi si pongono di fronte sono quindi numerose: da una parte la necessità di costruire, tassello per tassello, una mia identità professionale, dall’altra una realtà che vede un continuo ricalibrarsi delle identità individuali (D’Ambrosio 2020) poste di fronte alla prova del coronavirus; e ancora, da un lato la necessaria e imprescindibile valorizzazione della relazione terapeutica la quale ricopre un ruolo fondamentale “nelle attività di aiuto e di cura del benessere” (Stanzani 2007, 15), dall’altro l’impossibilità materiale e logistica di coltivare legami terapeutici adeguati ed in presenza. Insomma, la situazione è complessa ma, per quanto mi riguarda, non voglio tirarmi indietro.
Tragedie e catastrofi sembrano rappresentare “un’interferenza nell’equilibrio ordinario della società” (Pelosio 2016, 107), esse ci pongono dinnanzi alle nostre “vulnerabilità latenti” (Ibidem, 108), mettono, in altre parole, in risalto punti deboli nella struttura o nel sistema sociale (Pelosio 2016); sono elementi di rottura che sconvolgono l’ordine sociale ma che, allo stesso tempo, “si intersecano perfettamente con le funzioni del servizio sociale che si pone tra l’individuo, il suo bisogno e le risorse istituzionali e della comunità, in un’ottica di promozione, di sviluppo e valorizzazione” (Ibidem, 109); in tali frangenti molto importante è fare “massima attenzione ai problemi di ordine psicologico che possono manifestarsi nelle popolazioni colpite e nei loro soccorritori” (2) (Ibidem, 113), tenendo in debito conto che “la popolazione ha la necessità di avere risposte concrete e chiari riferimenti in tempi rapidi” (Ibidem, 119).
In simili contesti l’Assistente sociale è bersaglio di innumerevoli e svariate domande da parte di cittadini impauriti e psicologicamente fragili, lo spazio per la riflessività si riduce quasi a zero, mentre le risposte devono essere pressoché immediate. Oggi è proprio così: la realtà (e chi la abita) ci interpella e spesse volte possiamo sperimentare un forte senso di impotenza di fronte a sfide che ci paiono insolubili.
Eppure “sorella crisi” (Folgheraiter 2012) può anche farci scorgere nuove prospettive con cui affrontare il lavoro sociale in questi tempi funesti: può, ad esempio, illuminarci circa l’importanza di superare la logica del curing in favore del paradigma della care.
Mi spiego: l’Assistente sociale, di fronte alla crisi Coronavirus, può finalmente rinunciare alla pretesa di “salvare” chicchessia e abdicare a una sorta di funzione di “pronto soccorso sociale”, in favore di una care (3) intesa come, anziché “cura” in senso medico, un prendersi a cuore l’utente con il suo portato di angosce ma anche di risorse, di ansie e di qualità (Folgheraiter 2011). In quest’ottica l’operatore rinuncia a sostituirsi all’utente ed “assume la funzione del chiodo in una parete di roccia. Esso non si sostituisce alla forza di braccia dello scalatore ma si pone come punto di leva rendendo possibile che quella forza si finalizzi” (Folgheraiter 2018, 21).
Sempre questa crisi può permetterci di riscoprire il valore del counselling come “strategia di aiuto in cui l’operatore non ha il compito di fare qualcosa o di dare qualcosa a chi chiede aiuto; piuttosto egli ha la delicata funzione di aiutare la persona a definire il problema e imparare a gestirlo, assumendosi pienamente la responsabilità delle scelte compiute” (Simeone 2002, 74): un aiutare ad aiutarsi smuovendo l’individuo verso la comprensione del problema che procura disagio e la sua gestione attraverso adeguate scelte di cambiamento che ne conseguano. Alla base di tale modello terapuetico vi è una matrice antropologica buberiana (4) molto profonda nella cui visione “l’uomo è qualificato dalla relazione e può esistere soltanto nella relazione” (Ibidem, 88).
Una seconda matrice di assoluta centralità nel metodo counselling è quella fenomenologica, con particolare riguardo all’approccio di Eugenio Borgna, il quale molto si sofferma sull’importanza che assumono nel lavoro con le persone le parole ed i silenzi che le accompagnano: “le parole dell’ascolto e del silenzio” (Borgna 2017, 39), “che sappiano aiutare, indicare un cammino e portare al cuore degli utenti la speranza” (Ibidem, 127), l’ascolto gentile che si esplica nel fare attenzione, che significa “immedesimarsi sempre più a fondo nei pensieri e nelle emozioni, nelle attese e nelle speranze delle persone che stanno male e chiedono aiuto” (Ibidem, 41).
Una crisi, questa, che può farci riscoprire anche il valore dell’empatia, intesa come “processo di attivazione emotiva appropriato e consonante con quello di un’altra persona” (Bonino 2006, 25), come un vivere l’emozione dell’altro in modo vicario, senza sostituirsi ad esso ma condividendo a tratti il peso del dolore che porta, attraverso un forte decentramento emotivo e cognitivo (Bonino 2006).
Un’ennesima occasione che ci è data da questa terribile crisi è quella di riscoprire il valore del fronteggiamento come “azione libera di contrasto (in cui) il fine dell’azione è una contrapposizione o una tenace resistenza (resilience) a dei determinismi interni o esterni che si abbattono sulla vita dell’agente” (Folgheraiter 2011, 215). In altre parole: importante è valorizzare le capacità di resilienza dei singoli ovvero quel “processo dinamico che consente agli individui di reagire in maniera adattiva a situazioni stressanti, attivando meccanismi di coping che consentono di trasformare potenziali o reali minacce al proprio adattamento in opportunità di crescita e sviluppo” (Inguglia e Lo Coco 2013, 41), di riorganizzare la propria vita proattivamente in seguito a eventi traumatici come è il caso dell’epidemia oggi in atto (Inguglia e Lo Coco 2013).
Ruolo non certo secondario in questo contesto è quello imputabile al Segretariato sociale: infatti nell’attuale contesto caratterizzato da una pressante infodemia, ossia dalla “circolazione eccessiva delle diverse notizie attraverso molteplici fonti come stampa, tv, social network, talvolta non vagliate con accuratezza”, (Venturini 2020, 3) “il segretariato sociale, talvolta un pò “dimenticato”, trova uno spazio vitale ed indispensabile” (Cellini 2020), diventa strumento di corretta informazione e di orientamento circa la realtà dei fatti.
In una recente lettera che alcuni medici di Bergamo hanno inviato al New England Journal of Medicine si afferma la necessità, evidente in tale drammatico frangente, di un cambio di prospettiva che sostituisca un approccio patient-centered care con un approccio community-centered care, che veda al centro i bisogni della comunità prima ancora che quelli del singolo, con un connesso incremento dei servizi alla comunità oltre alla proposta meramente istituzionalizzata (l’ospedale). In calce a tale missiva si legge che “questa epidemia non è solo un fenomeno che riguarda la terapia intensiva, è una crisi umanitaria e di salute pubblica. Richiede l’intervento di scienziati sociali, epidemiologi, esperti di logistica, psicologi e assistenti sociali” (Nacoti, Ciocca et al, 2020). Simili dichiarazioni non fanno altro che accrescere in me la responsabilità circa il peso delle azioni che come professionisti possiamo compiere. Fare il bene o il male dipende da noi. La bellezza di questo mestiere è data proprio dal fatto che ha nell’uomo il suo centro e pertanto che fa dell’imprevedibilità umana la sua cifra: nessun modello e nessuna teoria lo può pienamente spiegare perché l’imponderabile e l’imprevedibile ne sono la cifra. Un uomo che oggi più di prima, percependosi debole e fragile, ha in sé una forte domanda di senso (Borgna 2017) e chiede di essere aiutato a rispondere a tale domanda, a scorgere nuovi orizzonti di senso, anche in questi frangenti in cui paure ed angoscie annebbiano il proprio guardare. “Portare al cuore degli utenti la speranza” (Ibidem, 127), “speranza a buon mercato, per un soldo ne darei, ad un solo cliente, quanto basta per sei” (Rodari 1960).
Note
- Utente, ente, ambiente sociale (Campanini 2002).
- Forte è il rischio di contagio psicologico (D’Ambrosio 2020; Dominelli 2020).
- Si veda Don Lorenzo Milani.
- Si rimanda a: M.Buber, Il principio dialogico e altri saggi, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2011.
La bibliografia completa è disponibile qui
*Assistente sociale